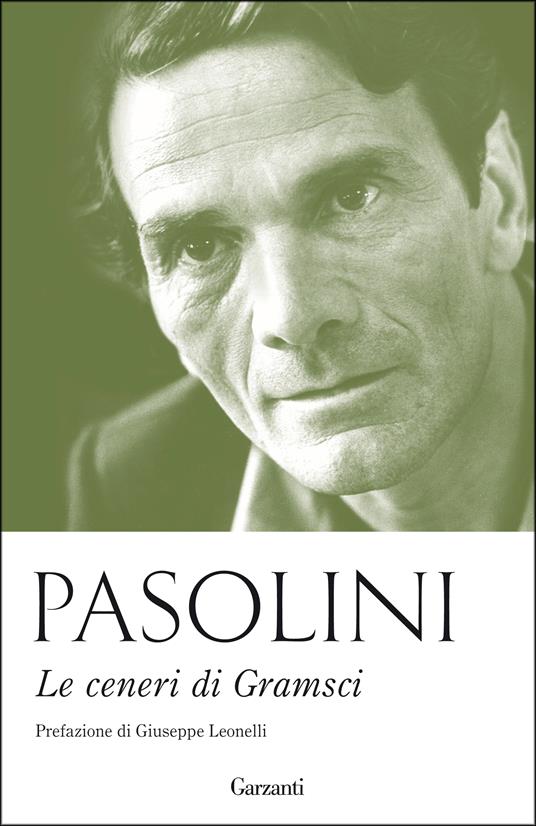L’ignavia come sistema: l’Italia tra indignazione intermittente e cultura dell’indifferenza
Oggi, di fronte a scelte istituzionali controverse o a silenzi giudicati ambigui, riemerge la stessa dinamica: si invoca un "popolo" ideale, mentre si ignora un dato elementare della democrazia rappresentativa. La maggioranza di chi si è recato alle urne ha scelto questo governo. Non un'entità astratta, non un'Italia immaginaria, ma persone reali, con le loro paure, convinzioni e aspettative hanno reso questo paese quello che è. Ed è da qui che bisogna partire, se si vuole comprendere davvero il presente; considerando un tratto che ritorna con ostinazione nella storia culturale italiana: la capacità di trasformare l'indignazione in un gesto episodico, quasi abituale, privo della continuità necessaria a incidere sulla realtà. È un fenomeno antico, sedimentato, che non riguarda solo la politica ma il modo stesso in cui gli italiani si percepiscono come cittadini. Una forma di ignavia che si rinnova, si adatta, si mimetizza sotto la sabbia per non alzare la testa.
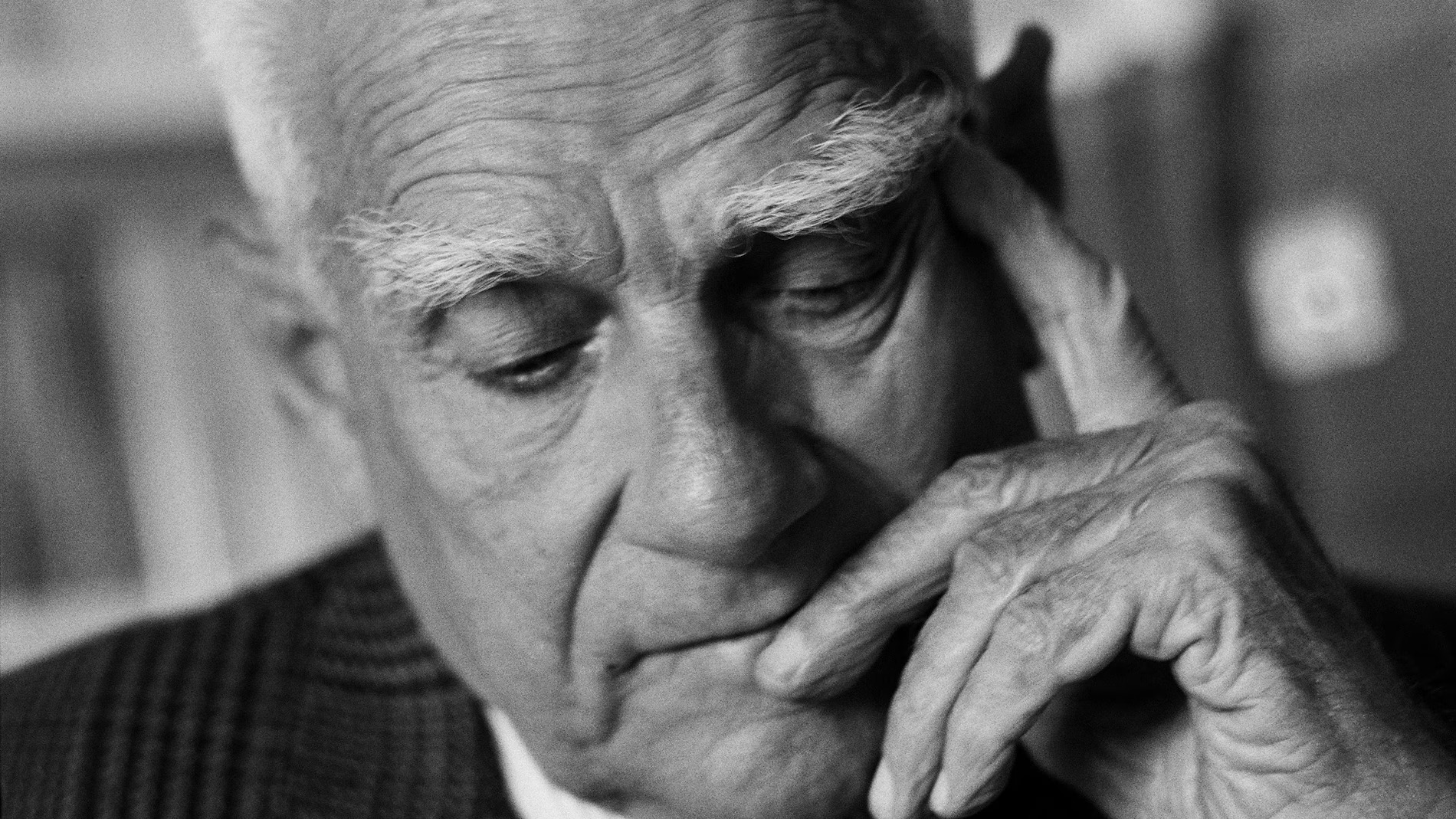
Moravia e la noia morale come condizione tutta italiana
Alberto Moravia aveva colto con precisione chirurgica che l'indifferenza non è un accidente, ma una postura. Gli indifferenti non è solo un romanzo: è un referto. La borghesia che descrive è paralizzata da una noia morale che diventa alibi, una forma di autoassoluzione permanente. Non agire, non esporsi, non scegliere: tutto viene ricondotto a un'eleganza dell'inerzia. Quella stessa noia continua a impregnare il nostro tempo. È la noia di chi osserva la politica come un teatro distante, senza riconoscere il proprio ruolo nella trama. È la noia di chi pretende cambiamenti radicali senza assumersi la fatica della partecipazione.
Il romanzo Gli indifferenti, forse il più celebre di Alberto Moravia, descrive la borghesia dei primi decenni del Novecento. A partire dal libro, Moravia racconta la sua vita, inclusa l'infanzia travagliata dalla tubercolosi ossea che lo avvicinò precocemente ai libri. Alberto Moravia (1907-1990) è stato uno dei più importanti romanzieri del XX secolo, oltre che poeta, reporter di viaggi, drammaturgo e critico cinematografico. Il suo sguardo penetrante e spietato sulla realtà italiana e sulle contraddizioni della società moderna, la lucida analisi dei temi della sessualità e dell'alienazione sociale, l'impegno politico e quello artistico percorsero tutta la sua vita e la sua opera, tradotti in una prosa asciutta e tagliente che caratterizza ogni suo scritto.
Montale e la figura dell'uomo che si ritrae
Eugenio Montale, con la sua figura dell'"uomo che non vuole", ha dato voce a un'altra forma di ignavia: quella dell'intellettuale che si sottrae, che preferisce la distanza alla responsabilità, che confonde la rinuncia con la profondità. È un tratto profondamente italiano: la convinzione che il non scegliere sia una forma di superiorità morale. Ma nei momenti di crisi questa postura diventa devastante. La democrazia non vive di sospensioni: vive di conflitto, di partecipazione, di scelte. L'astensione — prima ancora che elettorale, culturale — è il vero veleno lento della vita pubblica.
Montale e l'indifferenza: la poesia come diagnosi dell'uomo che si ritrae
In Montale l'indifferenza non è mai nominata apertamente, eppure è ovunque. È una presenza silenziosa, una postura esistenziale che attraversa Ossi di seppia, Le occasioni e La bufera e altro come un filo sotterraneo. Se Pasolini vede nell'indifferenza una complicità politica, Eugenio Montale la coglie come una condizione dell'anima italiana: un modo di stare al mondo che preferisce la ritrazione all'azione, il dubbio alla scelta, la contemplazione alla responsabilità.
La sua poesia è abitata da figure che non agiscono, che osservano, che si sottraggono. L'"uomo che non vuole" — una delle sue immagini più celebri — non è un vigliacco, ma un soggetto che ha interiorizzato la sfiducia nella storia, la percezione che ogni gesto sia destinato a dissolversi. È un uomo che non crede più nella possibilità di incidere, e proprio per questo si ritira. Non per cattiveria, ma per stanchezza metafisica.
Eugenio Montale non giudica questa postura: la registra. La mette in scena come un tratto profondamente italiano, una forma di difesa che diventa, però, anche una forma di resa. L'indifferenza, in Montale, non è mai un atto di volontà: è un esito. È ciò che resta quando la realtà appare troppo vasta, troppo incoerente, troppo resistente per essere trasformata.
In Ossi di seppia questa indifferenza assume la forma del paesaggio: la pietra, il secco, il mare che non consola. È un mondo in cui l'uomo è spettatore, non protagonista. In Le occasioni diventa invece una distanza affettiva, un'impossibilità di aderire pienamente alla vita. E in La bufera e altro si trasforma in una sorta di lucidità tragica: la consapevolezza che la storia — quella vera, quella che travolge — non lascia spazio all'illusione dell'azione individuale.
Eppure, proprio in questa rinuncia, Montale individua un punto di resistenza. L'indifferenza non è solo resa: è anche un modo per non essere catturati dal linguaggio del potere, per non farsi sedurre dalle retoriche della storia. L'uomo che si ritrae non è complice: è un sopravvissuto. È colui che, non potendo cambiare il mondo, almeno non si lascia cambiare da esso.
Montale non offre soluzioni, non propone alternative. Ma la sua poesia, con la sua voce scabra e antiretorica, è un invito a guardare l'indifferenza non come un difetto morale, ma come un sintomo. Un sintomo di una società che ha perso fiducia nella politica, nella storia, nella possibilità di un senso condiviso. Un sintomo che, se non riconosciuto, rischia di diventare destino.
In questo, Montale si colloca accanto a Moravia, Pasolini e Gramsci come una delle voci che hanno saputo leggere l'Italia non solo per ciò che fa, ma per ciò che evita di fare. La sua poesia è un atlante dell'inerzia, una mappa dell'esitazione, un catalogo delle forme che l'indifferenza assume quando diventa stile di vita.
E proprio per questo è ancora necessaria: perché ci ricorda che l'indifferenza non nasce dal nulla, ma da una lunga storia di disillusioni, di rinunce, di promesse mancate. E che comprenderla è il primo passo per superarla.
Pasolini e lo scandalo dell'indifferenza
Pasolini ha portato questa analisi al suo punto più radicale. Per lui l'indifferenza non era un vizio privato, ma una forma di complicità. Chi non vede, chi non parla, chi non prende posizione contribuisce, anche senza volerlo, al consolidarsi dei poteri. L'indifferente è parte del meccanismo. Pasolini non avrebbe avuto pazienza per l'indignazione intermittente, per la retorica del "popolo tradito" evocato solo quando serve. Avrebbe ricordato che la democrazia è un esercizio quotidiano, non un'emozione improvvisa. E che l'odio per gli indifferenti è sterile se non si accompagna alla capacità di convincere, educare, mobilitare. Pasolini non ha mai scritto un trattato sull'indifferenza, ma la sua idea dell'indifferenza come complicità, come parte organica del potere, attraversa in modo carsico tutta la sua produzione saggistica e poetica. Le opere in cui questo tema emerge con più forza — e che la critica riconosce come il suo pensiero politico più radicale — sono soprattutto i saggi civili degli anni Settanta.
Nell'opera di Pasolini l'indifferenza non è mai un semplice atteggiamento psicologico: è una categoria politica, un sintomo della trasformazione profonda che attraversa l'Italia del dopoguerra e che lui osserva con una lucidità quasi dolorosa. Dai versi de Le ceneri di Gramsci ai saggi di Scritti corsari e Lettere luterane, fino alle riflessioni teoriche di Empirismo eretico, Pasolini costruisce un'unica grande diagnosi: l'indifferenza è la forma moderna della complicità.
Per lui l'indifferente non è colui che "non sa", ma colui che non vuole sapere. È il soggetto che abdica alla responsabilità civile, che si lascia attraversare dalla storia senza opporvi resistenza, che accetta come inevitabile ciò che è semplicemente comodo. L'indifferenza diventa così il terreno fertile su cui attecchisce il nuovo potere: non più autoritario in senso classico, ma capace di omologare, sedurre, addormentare.
In Le ceneri di Gramsci questa indifferenza appare come una frattura: la distanza tra il popolo reale e la coscienza politica, tra la vita quotidiana e la storia. È un dolore che Pasolini sente sulla propria pelle, come se la sconfitta della sinistra fosse anche la sconfitta di un'idea di umanità vigile, partecipe, inquieta.
Negli Scritti corsari l'indifferenza diventa invece un fenomeno di massa. Pier Paolo Pasolini vede negli italiani una mutazione antropologica: non più cittadini, ma consumatori; non più soggetti politici, ma spettatori. L'indifferenza non è più un vizio privato, ma un dispositivo collettivo che permette al potere di consolidarsi senza opposizione. È la complicità silenziosa di chi non parla, non vede, non giudica, perché tutto è già stato normalizzato.
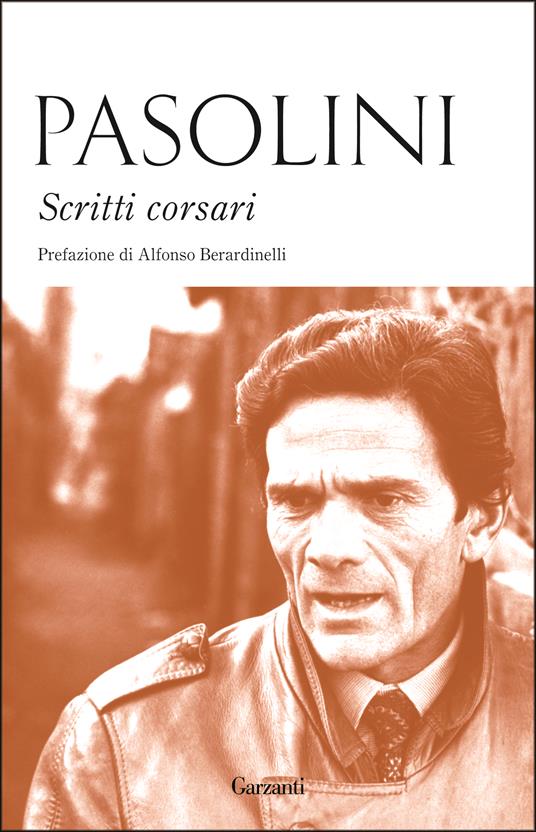
Nel «Corriere della sera» col titolo «Sfida ai dirigenti della televisione.» L'ultima parte dell'articolo (la sfida) è qui soppressa) Molti lamentano (in questo frangente dell'austerity) i disagi dovuti alla mancanza di una vita sociale e culturale organizzata fuori dal Centro «cattivo» nelle periferie «buone» (viste come dormitori senza verde, senza servizi, senza autonomia, senza più reali rapporti umani). Lamento retorico. Se infatti ciò di cui nelle periferie si lamenta la mancanza, ci fosse, esso sarebbe comunque organizzato dal Centro. Quello stesso Centro che, in pochi anni, ha distrutto tutte le culture periferiche dalle quali- appunto fino a pochi anni fa - era assicurata una vita propria, sostanzialmente libera, anche alle periferie più povere e addirittura miserabili. Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l'adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L'abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la «tolleranza» della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne all'organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema d'informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema d'informazioni è stata ancora più radicale e decisiva.
Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l'intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un'opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè - come dicevo - i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un «uomo che consuma», ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane. L'antecedente ideologia voluta e imposta dal potere era, come si s a , la religione: e il cattolicesimo, infatti, era formalmente l'unico fenomeno culturale che «omologava» gli italiani. Ora esso è diventato concorrente di quel nuovo fenomeno culturale «omologatore» che è l'edonismo di massa: e, come concorrente, il nuovo potere già da qualche anno ha cominciato a liquidarlo. Non c'è infatti niente di religioso nel modello del Giovane Uomo e della Giovane Donna proposti e imposti dalla televisione. Essi sono due Persone che avvalorano la vita solo attraverso i suoi Beni di consumo (e, s'intende, vanno ancora a messa la domenica: in macchina). Gli italiani hanno accettato con entusiasmo questo nuovo modello che la televisione impone loro secondo le norme della Produzione creatrice di benessere (o, meglio, di salvezza dalla miseria). Lo hanno accettato: ma sono davvero in grado di realizzarlo? No. O lo realizzano materialmente solo in parte, diventandone la caricatura, o non riescono a realizzarlo che in misura così minima da diventarne vittime. Frustrazione o addirittura ansia nevrotica sono ormai stati d'animo collettivi. Per esempio, i sottoproletari, fino a pochi anni fa, rispettavano la cultura e non si vergognavano della propria ignoranza. Anzi, erano fieri del proprio modello popolare di analfabeti in possesso però del mistero della realtà. Guardavano con un certo disprezzo spavaldo i «figli di papà», i piccoli borghesi, da cui si dissociavano, anche quando erano costretti a servirli. Adesso, al contrario, essi cominciano a vergognarsi della propria ignoranza: hanno abiurato dal proprio modello culturale (i giovanissimi non lo ricordano neanche più, l'hanno completamente perduto), e il nuovo modello che cercano di imitare non prevede l'analfabetismo e la rozzezza. I ragazzi sottoproletari - umiliati - cancellano nella loro carta d'identità il termine del loro mestiere, per sostituirlo con la qualifica di «studente». Naturalmente, da quando hanno cominciato a vergognarsi della loro ignoranza, hanno cominciato anche a disprezzare la cultura (caratteristica piccolo borghese, che essi hanno subito acquisito per mimesi). Nel tempo stesso, il ragazzo piccolo borghese, nell'adeguarsi al modello «televisivo» - che, essendo la sua stessa classe a creare e a volere, gli è sostanzialmente naturale - diviene stranamente rozzo e infelice. Se i sottoproletari si sono imborghesiti, i borghesi si sono sottoproletarizzati. La cultura che essi producono, essendo di carattere tecnologico e strettamente pragmatico, impedisce al vecchio «uomo» che è ancora in loro di svilupparsi. Da ciò deriva in essi una specie di rattrappimento delle facoltà intellettuali e morali. La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto «mezzo tecnico», ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. É il luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe dove collocare. É attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere. Non c'è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista e le scritte sui cascinali di slogan mussoliniani fanno ridere: come (con dolore) l'aratro rispetto a un trattore. Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l'anima del popolo italiano: il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione (specie, appunto, la televisione), non solo l'ha scalfita, ma l'ha lacerata, violata, bruttata per sempre.
In Lettere luterane questa analisi si fa ancora più radicale: la democrazia, dice Pasolini, non è un'emozione improvvisa, ma un esercizio quotidiano. L'indifferenza è la sua negazione. È la rinuncia alla fatica di capire, alla responsabilità di scegliere, alla necessità di educare e di educarsi. Senza questa fatica, la libertà resta un concetto astratto, una parola svuotata.
Infine, in Empirismo eretico, Pasolini mostra come il linguaggio stesso possa diventare veicolo di indifferenza: parole che non significano più nulla, discorsi che non incidono, comunicazione che non comunica. L'indifferenza diventa così anche una forma di impoverimento simbolico, una perdita di senso che precede e prepara la perdita di coscienza.
In tutte queste opere, Pier Paolo Pasolini non si limita a denunciare: tenta di scuotere, di provocare, di richiamare alla responsabilità. L'indifferenza, per lui, è il vero nemico della storia, perché è ciò che permette al potere di agire indisturbato. E l'unico antidoto è l'intelligenza critica, la partecipazione, la capacità di vedere ciò che gli altri non vogliono vedere.
Gramsci: dall'odio per gli indifferenti all'intelligenza come responsabilità
E poi c'è Antonio Gramsci, che apre i suoi scritti con un'esplosione: «Odio gli indifferenti». Ma non si ferma lì. Per lui il disprezzo è solo l'inizio, un punto di rottura. Subito dopo viene l'intelligenza, che è la vera arma politica dei "senza potere".
Antonio Gramsci non si limita a denunciare l'ignavia: la analizza, la smonta, la riconduce ai suoi meccanismi concreti. La nullità della classe politica, il trasformismo, la fragilità delle istituzioni, l'astrattezza della libertà, il perbenismo, la disintegrazione del linguaggio pubblico: sono tutti sintomi di una malattia più profonda, che lui osserva con una lucidità che ancora oggi brucia nella contemporaneità delle nostre esistenze e resistenze.
Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che «vivere vuol dire essere partigiani». Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. È la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costrutti; è la materia bruta che si ribella all'intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare non è tanto dovuto all'iniziativa dei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità che sembra dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo assenteismo. Dei fatti maturano nell'ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano, di procurare quel tal bene si proponevano. I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di fallimenti ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E non già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non siano capaci di prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, ma questo contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale; è prodotto di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di nessun genere. Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto a ognuno di essi del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene che l'attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato, perché non è riuscito nel suo intento. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
11 febbraio 1917
Odio gli indifferenti, Antonio Gramsci
Il suo metodo è opposto all'indignazione sterile: ascoltare, osservare, capire, restare nella realtà anche quando fa male.
Il ricordo di Terracini — Gramsci che entra in silenzio, si siede in un angolo, ascolta tutto — è l'immagine più potente della sua politica: non l'uomo che parla per primo, ma quello che parla per ultimo perché ha ascoltato tutti.
Gramsci è il punto in cui la genealogia dell'indifferenza italiana si rovescia: non più la diagnosi, ma il tentativo di una cura.
La realtà che non si vuole vedere
Molti oggi denunciano ambiguità, timidezze, complicità. Ma ignorano un fatto semplice: la maggioranza di chi ha votato ha scelto questo esecutivo. La domanda, allora, non è come sia possibile che questo governo esista. La domanda è perché non si sia riusciti a costruire un'alternativa capace di convincere abbastanza persone.
È qui che l'indignazione si scontra con la realtà. Ed è qui che l'ignavia si manifesta nella sua forma più sottile: non nell'astensione altrui, ma nell'incapacità di chi critica di trasformare il dissenso in progetto, il malcontento in proposta, la protesta in consenso.
Spezzare la genealogia dell'indifferenza
Moravia ci ha mostrato la radice, Montale la forma, Pasolini la conseguenza. Gramsci ci offre il metodo per uscirne: intelligenza, ascolto, responsabilità.
Sta a noi decidere se restare dentro questa genealogia dell'indifferenza o provare a spezzarla. La democrazia non si difende con la retorica dell'indignazione, ma con la responsabilità della partecipazione. Non con il disprezzo per chi non vota, ma con la capacità di convincerlo a farlo.
Il resto è rumore. E l'Italia, di rumore, ne ha già abbastanza.
Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...
Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine
Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...
È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.