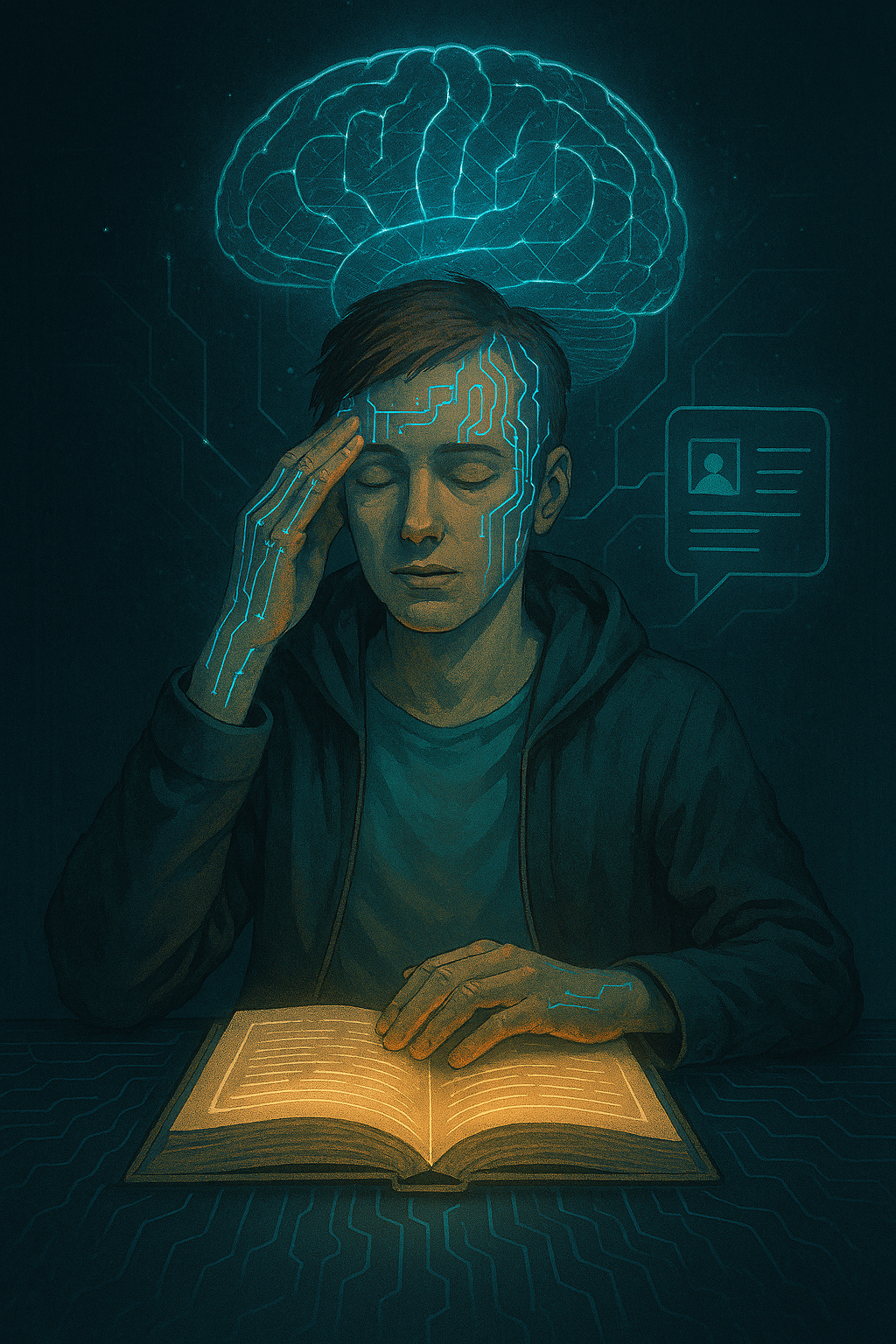Renad Attallah: la resilienza come linguaggio, la speranza come destino
Ci sono storie che non chiedono di essere ascoltate: impongono la loro presenza, come un varco nella coscienza collettiva. La storia di Renad Attallah appartiene a questa categoria rara. Non perché sia eccezionale nel senso spettacolare del termine, ma perché è una storia che, pur provenendo da un luogo devastato, non cede mai alla devastazione. È la storia di una bambina che ha imparato troppo presto cosa significa perdere, attendere, sopravvivere. E che, nonostante tutto, continua a generare vita.
Renad ha undici anni. È uscita da Gaza, ma non si definisce una sopravvissuta: la sua famiglia è ancora lì, e la sopravvivenza — per lei — non è un fatto individuale, ma un destino condiviso. È una definizione che dice molto della sua maturità, e ancora di più della sua ferita. Nella casa olandese dove ora vive con la sorella maggiore e il fratello gemello, la sicurezza è un bene nuovo, quasi straniero. Eppure, anche in questa nuova quiete, il passato non smette di bussare: basta il rumore di un aereo nel cielo per riportarla mentalmente a Gaza, a quel ronzio di droni che era diventato la colonna sonora della sua infanzia.

La cucina come atto di resistenza
Renad è diventata nota per le sue ricette "allo stile di Gaza", preparate con ciò che riusciva a trovare sotto i bombardamenti. Non era un gioco, non era un passatempo: era un modo per restare viva, per restare bambina, per trasformare la scarsità in creatività. La cucina, per lei, non è mai stata solo nutrimento: è identità, memoria, appartenenza. È un modo per dire "ci siamo ancora", anche quando tutto intorno sembra voler dimostrare il contrario.
Oggi, in Olanda, ha smesso per un po' di pubblicare ricette. Non le sembra giusto cucinare mentre la sua gente soffre la fame. È un gesto che rivela una coscienza etica sorprendente per la sua età: la consapevolezza che la gioia, per essere autentica, non può ignorare il dolore degli altri.
Eppure, proprio in questo silenzio temporaneo, la cucina continua a essere la sua promessa: un giorno tornerà a farlo, dice, e vuole diventare una chef famosa. Non per vanità, ma per trasformare la sua storia in un messaggio "forte e chiaro".
Il viaggio come ferita e rinascita
Il viaggio che ha portato Renad e i suoi fratelli fuori da Gaza è stato un attraversamento di frontiere, attese, controlli, silenzi. Hanno lasciato la Striscia con addosso solo i vestiti, un telefono, un caricabatterie e 300 dollari. Nourhan, la sorella maggiore, aveva vinto una borsa di studio: un varco minuscolo in un muro apparentemente invalicabile. Hanno attraversato Rafah — "completamente distrutta" — poi Israele, la Cisgiordania, la Giordania, fino a un aeroporto militare in Belgio, e infine Maastricht. Il viaggio che ha condotto Renad fuori da Gaza non può essere interpretato come una liberazione nel senso pieno del termine. Non è stato un atto risolutivo, né una fuga che cancella il passato e inaugura il futuro. È stato, piuttosto, una sospensione: un intervallo fragile tra il pericolo e la protezione, tra la devastazione e la possibilità. Essere al sicuro, fisicamente, non equivale a essere liberi interiormente. La sicurezza, quando non è condivisa con chi si ama, diventa una forma di inquietudine sottile, una colpa che non ha nome ma che si insinua nei gesti quotidiani, nei pensieri notturni, nei silenzi che si allungano.
La consapevolezza che la propria famiglia è rimasta nel cuore del conflitto trasforma ogni gesto di quiete in un atto ambivalente: da un lato c'è il sollievo, dall'altro il peso. E questo peso non si dissolve con il tempo, non si attenua con la distanza. È una forma di dolore che non si risolve, perché non cerca una soluzione. Si indossa come si porta una cicatrice invisibile, come si porta una lingua che non si parla più ma che continua a risuonare dentro. Si porta come si porta la memoria di un luogo che non si può più abitare, ma che continua ad abitare noi.
In questo senso, il viaggio di Renad non è stato una fuga, ma una traslazione esistenziale: il corpo si è spostato, ma l'anima è rimasta in bilico. E proprio in questa sospensione — in questo spazio intermedio tra il prima e il dopo — si manifesta la resilienza più autentica: quella che non grida, che non si celebra, ma che continua a vivere nel silenzio, nella cura, nella speranza che un giorno, anche chi è rimasto indietro, possa attraversare lo stesso varco.
Eppure, quando Renad racconta il suo primo incontro con un ristorante italiano, o la sorpresa di poter mangiare verdure dopo mesi, la sua voce si illumina. La speranza, in lei, non è un concetto astratto: è un gesto quotidiano, un sapore ritrovato, una lingua nuova da imparare.
La scuola come ritorno all'infanzia
Dopo due anni senza lezioni, Renad è tornata a scuola. È forse il dettaglio più semplice, e al tempo stesso il più rivoluzionario: una bambina che torna a essere bambina. Studia inglese, impara l'olandese, fa amicizia con altri studenti arrivati da zone di guerra. Il primo giorno, una compagna l'ha riconosciuta: "Sei Renad? Davvero sei Renad?". In quella domanda c'è un riconoscimento che va oltre la notorietà: è il riconoscimento di una storia che ha toccato il mondo.
Eppure, anche qui, la resilienza non cancella la ferita. Renad ha perso un'amica sotto i bombardamenti. Ha perso la routine, la normalità, la continuità. Eppure, continua a imparare. Continua a crescere. Continua a sperare.
La speranza come responsabilità
C'è una frase che Nourhan pronuncia quasi senza pensarci: "Da palestinese penso che nessuno di noi starà davvero bene finché non sarà finito il genocidio". Perché la speranza, per loro, non è un lusso: è un dovere. È ciò che permette di immaginare un futuro in cui i bambini possano essere bambini, in cui la cucina torni a essere festa, in cui il rumore degli aerei non significhi più paura.
Renad, con la sua voce limpida e la sua determinazione, incarna questa speranza. Non una speranza ingenua, ma una speranza resistente: quella che nasce non dall'assenza del dolore, ma dalla capacità di attraversarlo senza lasciarsi definire da esso.
Una bambina che diventa simbolo
La forza di Renad non sta nel suo essere un'icona mediatica, ma nel suo essere profondamente umana. È una bambina che ride, che scherza con la sorella, che sogna di viaggiare e imparare lingue. È una bambina che porta con sé la memoria del padre, trovata per caso in alcune fototessere nascoste nella carta d'identità. È una bambina che, pur vivendo oggi in un luogo sicuro, continua a sentire il richiamo della sua terra.
E proprio per questo, la sua storia è potente: perché non è una storia di fuga, ma di continuità. Non è una storia di vittimismo, ma di dignità. Non è una storia di fine, ma di inizio.
Negli ultimi decenni la società ha attraversato una trasformazione radicale che ha inciso in profondità sul modo in cui gli esseri umani vivono l'amore, l'intimità e la relazione. L'avvento della tecnologia digitale ha permeato ogni dimensione dell'esistenza, ridefinendo i ritmi della vita quotidiana, le forme della comunicazione e persino la...
Ci sono storie che non chiedono di essere ascoltate: impongono la loro presenza, come un varco nella coscienza collettiva. La storia di Renad Attallah appartiene a questa categoria rara. Non perché sia eccezionale nel senso spettacolare del termine, ma perché è una storia che, pur provenendo da un luogo devastato, non cede mai alla devastazione....
Essere nel mondo oggi significa abitare un ambiente informativo che non ha precedenti nella storia dell'umanità, un ecosistema nel quale la presenza dell'individuo coincide con la sua connessione, con la sua capacità di interagire con il popolo della rete, di ricevere e distribuire informazioni, di orientarsi in un flusso continuo di stimoli che...