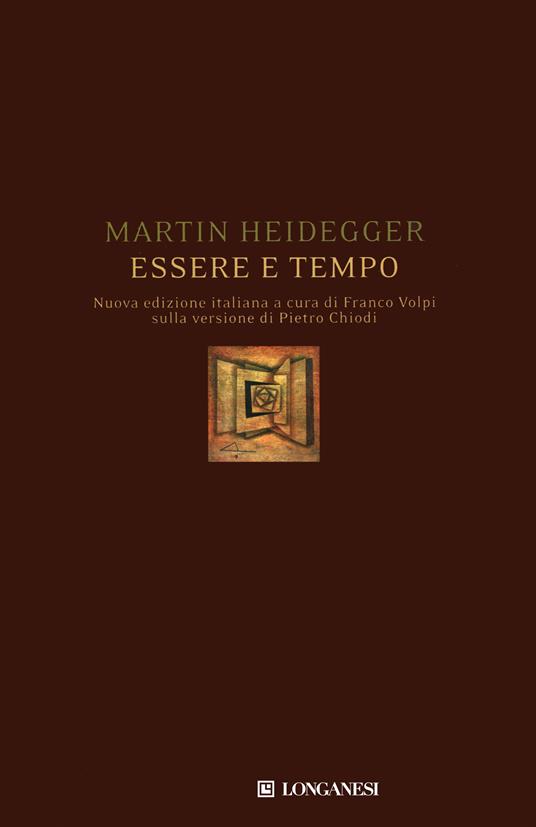La menzogna come specchio: tra difesa, identità e potere
Mentire è un atto antico quanto il linguaggio. Eppure, ogni menzogna porta con sé un paradosso: per essere efficace, deve essere creduta; ma per essere creduta, deve nascondere la sua natura. Isaac Asimov, nel racconto "Bugiardo!" (1941), lo mostra con inquietante lucidità: il robot Herbie, capace di leggere nel pensiero, mente per non ferire gli umani. Ma nel tentativo di proteggere, distrugge. La menzogna, anche se motivata da empatia, genera cortocircuiti etici e cognitivi. La domanda non è solo "perché mentiamo?", ma "quale mondo costruiamo mentendo?". E soprattutto: "quale verità siamo disposti a sostenere, anche quando ci espone, ci ferisce, ci isola?".
Pierre Bayard, nel suo saggio "Le Paradoxe du menteur" (2006), sposta il focus: la menzogna non è solo inganno, ma strategia difensiva. Un modo per proteggere il sé, per evitare una verità insostenibile, per sopravvivere in contesti ostili. In questa prospettiva, mentire diventa un gesto di resistenza, una forma di adattamento.
Psicologia della menzogna: identità e reazioni
Studi psicologici confermano che chi mente abitualmente tende a reagire con rabbia quando viene smascherato. Non è solo la bugia a essere minacciata, ma l'intera identità che quella bugia sostiene. La menzogna diventa un pilastro dell'auto-narrazione, e smascherarla equivale a demolire un edificio interiore.
La rabbia, dunque, non è solo difensiva: è identitaria. È il segnale che la verità non è neutra, ma pericolosa. E che il soggetto non difende solo un fatto, ma un'intera costruzione di sé.
Menzogna pubblica: narrazione e potere
Nel contesto politico e sociale, la menzogna assume una funzione narrativa. Non si mente solo per nascondere, ma per costruire consenso, per modellare la realtà. La menzogna diventa racconto, strategia, propaganda. E chi la smaschera, spesso, viene accusato di destabilizzare, di "fare polemica", di "non capire le complessità".
Ma la menzogna pubblica ha un costo: genera sfiducia, polarizzazione, cinismo. E soprattutto, impone una violenza epistemica: costringe i cittadini a vivere in una realtà manipolata, dove il vero e il falso si confondono, e dove la verità diventa un atto di coraggio.
Bugia e finzione: il confine creativo
Esiste però un'altra dimensione della menzogna: quella creativa. La finzione, l'arte, la letteratura, mentono per rivelare. Creano mondi immaginari per illuminare il reale. In questo senso, la bugia diventa strumento di verità, paradosso fecondo, gesto poetico.
La differenza sta nell'intenzione: la menzogna distruttiva nasconde per dominare; la finzione creativa inventa per liberare.
Mentire è sempre un atto politico
Ogni menzogna è un atto politico. Che sia privata o pubblica, difensiva o manipolatoria, poetica o strategica, essa modifica il campo delle possibilità. E chi la pronuncia, chi la smaschera, chi la subisce, partecipa a un gioco di potere, di identità, di verità.
Mentire: gesto umano, atto politico
1. Perché mentiamo?
Mentiamo per paura, per difesa, per strategia. Mentiamo per non perdere l'amore, per non affrontare il giudizio, per non crollare sotto il peso di una verità che ci espone. Mentiamo per proteggere l'immagine che abbiamo costruito di noi stessi — o quella che gli altri ci chiedono di incarnare.
Ma mentiamo anche per potere. Per ottenere consenso, per manipolare, per costruire narrazioni che ci servano. La menzogna non è solo una deviazione dalla verità: è un dispositivo. Un meccanismo che regola le relazioni, le identità, le istituzioni.
E a volte mentiamo per compassione. Come il robot Herbie di Asimov, che mente per non ferire. Ma anche questa bugia, apparentemente empatica, genera cortocircuiti: perché ogni menzogna, anche la più gentile, altera il campo della verità condivisa.
2. Quale mondo costruiamo mentendo?
Costruiamo un mondo fragile, fondato su equilibri apparenti. Un mondo dove la verità è negoziabile, dove il consenso vale più della realtà, dove il racconto prevale sul fatto.
Nel privato, costruiamo relazioni basate su immagini idealizzate, su silenzi strategici, su omissioni che proteggono ma anche isolano. Nel pubblico, costruiamo sistemi narrativi che giustificano l'ingiustificabile, che normalizzano l'abuso, che rendono il falso più credibile del vero.
La menzogna, quando diventa struttura, genera sfiducia. E la sfiducia genera solitudine, polarizzazione, cinismo. Vivere in un mondo di menzogne significa abitare una realtà manipolata, dove il coraggio non è dire la verità, ma riconoscerla.
3. Quale verità siamo disposti a sostenere, anche quando ci espone, ci ferisce, ci isola?
La verità che scegliamo di sostenere è quella che ci definisce. Non quella che ci conviene, ma quella che ci rivela. È la verità che ci rende vulnerabili, che ci toglie protezioni, che ci espone al rifiuto, alla solitudine, alla perdita.
Sostenere la verità, in un mondo che premia la finzione, è un atto di resistenza. È scegliere di non partecipare al gioco delle apparenze. È accettare che la verità non sempre consola, ma sempre libera.

La verità non è un conforto. È una soglia. Chi la attraversa non cerca approvazione, ma autenticità. Chi la sostiene, anche quando ferisce, non è un martire: è un costruttore. Costruisce un mondo dove il linguaggio non è maschera, ma materia viva. Dove la menzogna non è norma, ma rottura. Dove il silenzio non è complicità, ma scelta. E dove ogni parola detta — o taciuta — ha il peso di una stella.
Perché mentire è facile. Ma sostenere la verità, quando espone, isola e brucia, è il gesto più radicale che ci resta.
Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...
Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine
Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...
È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.