C'è un punto, in Vie privée, in cui la tensione smette di essere un semplice dispositivo narrativo e diventa un metodo di conoscenza. Rebecca Zlotowski costruisce il suo film come un'indagine che non mira a risolvere un enigma, ma a smascherare la fragilità strutturale di chi indaga. Lilian, psicanalista in crisi, non è l'eroina che...
Tradizione e modernità: una riflessione critica a partire da Julius Evola
Il libro Rivolta contro il mondo moderno (1934) di Julius Evola rappresenta una delle opere cardine del pensiero tradizionalista europeo del Novecento. Evola vi delinea una visione della storia fondata sul concetto di Tradizione primordiale, intesa come principio universale e metastorico, da cui le civiltà avrebbero progressivamente deviato.
Il cuore della visione evoliana
Secondo Evola, le società antiche erano rette da un ordine sacro e gerarchico: al vertice vi era l'aristocrazia spirituale e guerriera, custode del senso del sacro e del legame con il divino. Lungo i secoli, questo modello sarebbe stato minato da processi di degenerazione: dal prevalere della materia sullo spirito, dell'economia sulla politica, dell'eguaglianza sull'ordine gerarchico, fino a giungere all'età contemporanea segnata da individualismo, materialismo e tecnica.
In questa prospettiva, la modernità appare come il culmine della dissoluzione, mentre il compito dell'uomo "differenziato" sarebbe quello di opporsi interiormente e spiritualmente a tale decadenza, mantenendo una postura aristocratica e guerriera contro il mondo "profano".
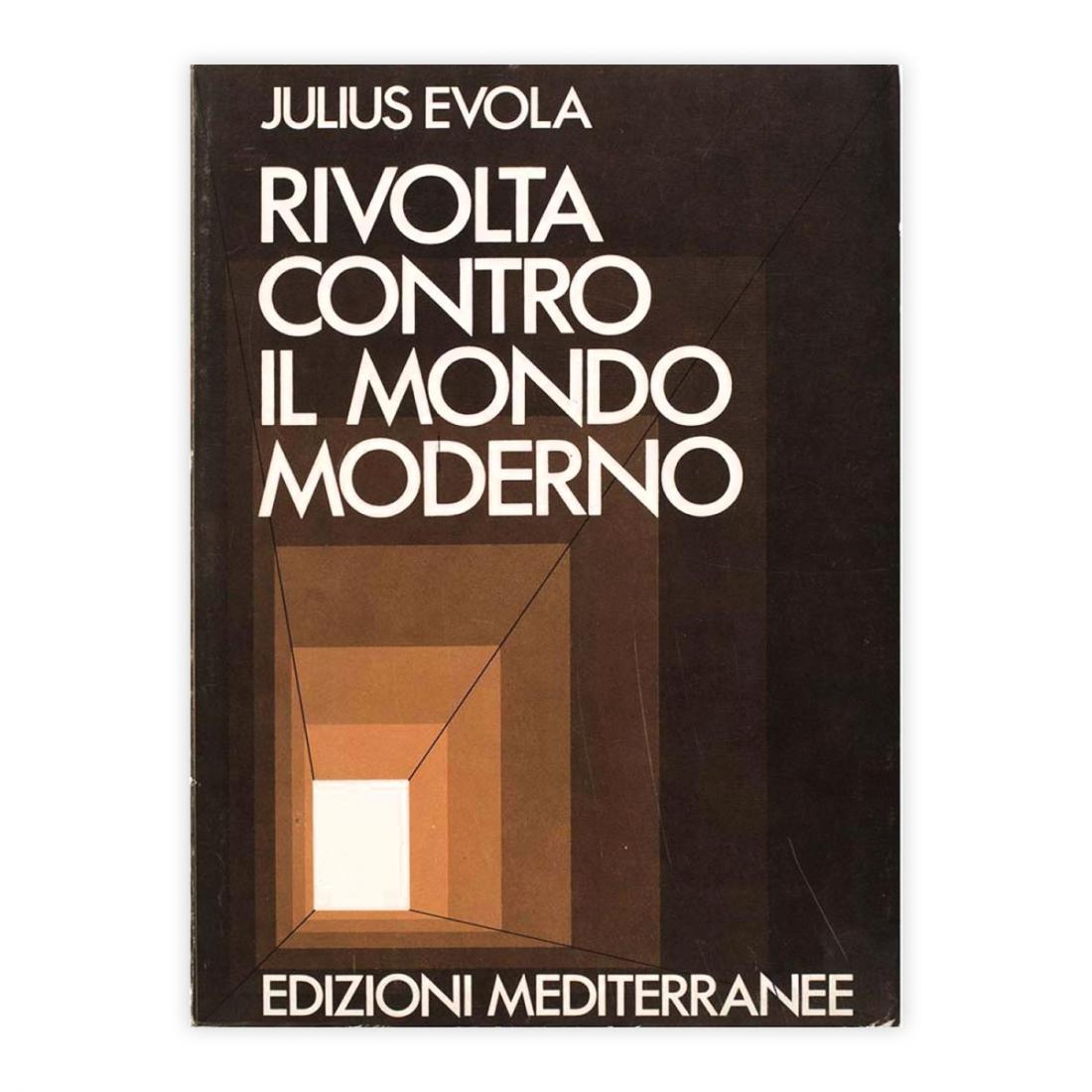
La seduzione di un mito
Questa narrazione affascina per la sua potenza simbolica: il richiamo a un'origine luminosa, la concezione ciclica del tempo, la nostalgia di un ordine perduto, la promessa di un'aristocrazia interiore che resiste alla crisi. Tuttavia, è proprio nella seduzione del mito che si annidano i rischi. La sacralizzazione della gerarchia tende a giustificare strutture sociali autoritarie, in cui la dignità della persona viene subordinata a un presunto ordine "superiore". L'idea di élite spirituale può trasformarsi in giustificazione di esclusioni, discriminazioni o forme di dominio, dove pochi si arrogano il diritto di definire cosa sia "tradizione" e cosa no. La critica della modernità, pur cogliendo reali derive (materialismo, consumismo, alienazione), scivola in un rifiuto complessivo di valori come l'uguaglianza, la libertà e i diritti, conquiste fondamentali della civiltà umana.
Dalla filosofia al rischio ideologico
Non a caso, le idee di Evola sono state spesso assorbite da ambienti politici che hanno cercato di trarne legittimazione per ideologie autoritarie e antidemocratiche, costruendo una retorica di "difesa della tradizione" che maschera pratiche di esclusione, oppressione e violenza.
Il pericolo di questa impostazione è quello di trasformare la ricerca spirituale in un progetto di potere: da filosofia metafisica, la Tradizione diventa un'arma ideologica per giustificare gerarchie sociali rigide, marginalizzazione dei "diversi" e rifiuto delle libertà individuali.
Un approccio umanistico
Eppure, alcune intuizioni di Evola possono essere recuperate se liberate dal loro impianto dogmatico: la critica all'eccesso di materialismo, la consapevolezza della dimensione spirituale dell'uomo, la necessità di un senso che trascenda il mero consumo. Tuttavia, questo deve avvenire in un'ottica umanistica, che ponga al centro la dignità della persona, il dialogo interculturale, la libertà e la responsabilità condivisa.
Il compito non è dunque una "rivolta contro il mondo moderno", ma piuttosto un ripensamento del moderno: costruire una società capace di integrare progresso tecnico e sensibilità spirituale, libertà individuale e giustizia sociale, senza ricadere in mitologie di potere che si sono già rivelate, storicamente, aberranti.
Guardare negli occhi il male
Ogni epoca ha i suoi demoni. Non vivono solo nei libri, nei miti o nelle dottrine oscure: abitano dentro di noi, sussurrano con la voce della paura, del dominio, della violenza. Julius Evola, con la sua Rivolta contro il mondo moderno, ha dato a questi demoni un volto: la dissoluzione, la perdita della gerarchia, l'oscuramento del sacro. Ma ciò che egli propose come rimedio — il ritorno a un ordine rigido, gerarchico e aristocratico — non fa che alimentare un altro demone, più sottile e insidioso: quello della sopraffazione, della disumanizzazione, dell'uomo che si erge giudice sull'uomo.
Guardare negli occhi il male significa riconoscere che esso non è solo "fuori", nella modernità o nella tecnica, ma "dentro": nel desiderio di potere, nella volontà di ridurre l'altro a strumento, nella tentazione di credere che alcuni abbiano più diritto di altri a esistere.
E tuttavia, è proprio in questa lotta che si misura la grandezza dell'uomo. Non attraverso la fuga in un passato idealizzato, né mediante la costruzione di piramidi sociali che schiacciano la persona, ma attraverso una rivolta più profonda: quella della coscienza contro l'odio, della compassione contro l'indifferenza, della libertà contro il dominio.
Il vero eroismo oggi non è difendere una gerarchia, ma custodire la dignità che accomuna ogni essere umano. Il vero atto aristocratico non è il privilegio di pochi, ma la capacità di guardare l'altro come un volto, non come un numero o una funzione.
Così, sfidando i demoni dentro di noi, possiamo scoprire che l'umanità non è condanna, ma promessa. La Tradizione da recuperare non è quella di un impero perduto o di un'età mitica, bensì quella più antica e più semplice: il legame che unisce ogni coscienza alla coscienza dell'altro.
È in questa alleanza invisibile che l'uomo può vincere il male. Non con la spada, non con il mito di pochi eletti, ma con il coraggio di affermare, anche nell'oscurità del tempo presente, che l'umanesimo è la nostra vera rivoluzione.
Manifesto della rivolta Umanistica
C'è un male che non indossa uniforme, né bandiera, né ideologia.
È il male che si annida in ogni cuore quando dimentica che l'altro è un volto anziché un nemico.
È il demone che ci tenta con promesse di grandezza, che ci sussurra:
"Dividi, domina, innalzati sopra gli altri".
Lo abbiamo incontrato nei secoli: nelle piramidi sociali che schiacciano, nei templi eretti al potere, nelle gerarchie che scambiano la sacralità con la violenza.
E ancora lo incontriamo oggi: nei mercati che divorano le coscienze, nelle ideologie che vestono il rancore di splendidi miti, nei meccanismi che trasformano la vita in numero, merce, strumento.
Ma la nostra rivolta non è nostalgia di imperi perduti.
Non cerchiamo un'età dell'oro sepolta né un'aristocrazia che ci dica chi vale e chi no.
La nostra rivolta è più radicale: nasce nello sguardo che riconosce l'altro come fratello, anche quando è straniero, anche quando ci spaventa.
Guardare il male negli occhi non significa imitarlo, né erigere nuove catene con il nome della Tradizione.
Significa spezzare l'incantesimo che ci fa credere che la forza sia privilegio, che il potere sia destino, che la storia sia soltanto una caduta verso il nulla.
Noi affermiamo che l'umanità non è condanna, ma promessa.
Che dentro ogni coscienza vi è una scintilla più antica di ogni impero e più luminosa di ogni gerarchia.
Che il vero sacro è ciò che unisce, non ciò che divide.
Per questo la nostra lotta non è contro il mondo moderno,
ma contro l'ombra che cresce quando dimentichiamo la nostra comune dignità.
È una lotta senza armi, ma con parole di verità, gesti di compassione, atti di coraggio silenzioso.
Il futuro non appartiene ai pochi che vogliono elevarsi sopra gli altri,
ma ai molti che scelgono di camminare insieme, liberi e responsabili,
custodi della fragile grandezza che chiamiamo umanità.
Questa è la vera rivolta:
non il ritorno a un passato mitico, ma l'avvento di un umanesimo vivo,
capace di guardare i demoni negli occhi e dire loro, con voce ferma:
"Tu non avrai l'ultima parola.
Perché l'ultima parola è la dignità dell'uomo".
Nel panorama dell'arte contemporanea brasiliana, Jonathas de Andrade occupa da anni una posizione singolare: la sua pratica, sospesa tra documentario e finzione, indaga le fratture della memoria collettiva, le tensioni tra identità e potere, le forme sottili attraverso cui le comunità costruiscono — e difendono — la propria storia. La sua opera...


