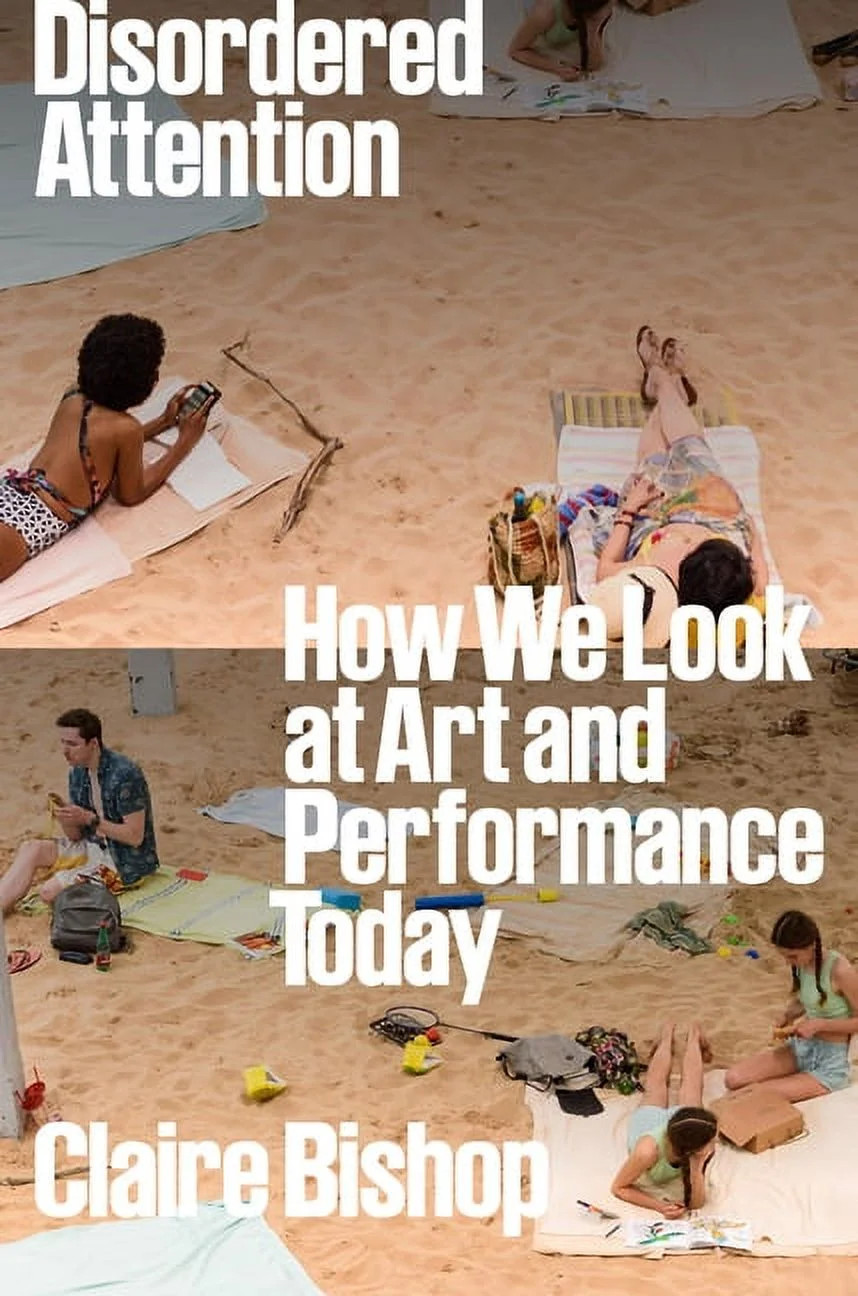Lo sguardo distratto e la resistenza degli artisti
Negli ultimi decenni, la percezione del pubblico nei confronti dell'arte ha subito una trasformazione radicale. Claire Bishop, nel suo recente Disordered Attention: How We Look at Art and Performance Today, mette a fuoco un fenomeno che tutti avvertiamo: lo sguardo sempre più rapido, intermittente, distratto, modellato dall'ecosistema digitale. L'arte, un tempo luogo privilegiato della contemplazione, si trova oggi a competere con la logica dello "scrolling" e con la frammentazione dell'attenzione. Dal nuovo libro di Claire Bishop ad altre voci della critica contemporanea.
La diagnosi di Bishop
Bishop individua una tensione tra arte come esperienza lenta e arte come stimolo immediato. Gli artisti reagiscono in due direzioni: alcuni cercano di catturare l'attenzione con opere immersive, interattive, multisensoriali; altri rivendicano la lentezza come gesto politico, un invito a sottrarsi alla frenesia digitale. La critica sottolinea anche il ruolo crescente dell'artivismo, dove l'opera diventa strumento di mobilitazione sociale e non solo estetica. Il nuovo libro di Claire Bishop non è un punto di arrivo, ma un nodo in una rete di riflessioni che da Bourriaud a Crary, da Groys a Foster, ci aiutano a comprendere come l'arte reagisce alla crisi dell'attenzione.
Per chi vuole iniziare, questi testi sono porte d'ingresso verso un dibattito vivo e necessario: l'arte come spazio di lotta contro la distrazione permanente.
Perché questi testi parlano anche ai non specialisti
Offrono strumenti concettuali per capire come l'arte risponde alle trasformazioni sociali e tecnologiche, mostrando che la questione non è solo estetica, ma riguarda il nostro modo di vivere, percepire e relazionarci. Invitano inoltre a leggere l'arte come laboratorio di resistenza: un luogo dove si sperimentano nuove forme di attenzione, lentezza e comunità. Quando diciamo che questi testi "offrono strumenti concettuali", intendiamo che non si limitano a descrivere l'arte, ma ci danno categorie, linguaggi e prospettive per interpretarla nel suo contesto più ampio. Non guardano solo all'opera, ma a ciò che l'opera fa nel mondo.
Claire Bishop ci parla di attenzione disordinata: un concetto che ci aiuta a capire come il nostro modo di guardare sia cambiato con l'avvento dei social media, dello streaming, della velocità digitale. Jonathan Crary ci offre per esempio l'idea di un mondo "24/7", dove non c'è più spazio per il riposo, la contemplazione, il silenzio. L'arte, in questo contesto, può diventare un luogo dove queste esperienze vengono difese. Questi concetti non sono solo teorici: ci aiutano a leggere il nostro presente, a capire perché certe opere ci colpiscono, ci disturbano, ci fanno pensare.
Artisti contemporanei come teamLab, Tino Sehgal e Agnes Martin incarnano le due principali reazioni alla crisi dell'attenzione: immersione tecnologica e resistenza contemplativa. Le loro opere offrono esempi concreti e accreditati di come l'arte risponda alle trasformazioni percettive del pubblico. Questi esempi mostrano come l'arte contemporanea sia divisa tra due tensioni: quella che cerca di catturare lo sguardo in fuga e quella che invita a rallentare, a resistere. In entrambi i casi, l'opera diventa un luogo dove si gioca la nostra capacità di attenzione, relazione e presenza.
Questi artisti e collettivi creano esperienze multisensoriali, spesso digitali, pensate per coinvolgere uno spettatore abituato a stimoli rapidi e continui.
teamLab (Giappone)
Collettivo di artisti, programmatori e ingegneri.
Celebre per le installazioni immersive come Borderless e Planets a Tokyo.
Le opere sono ambienti digitali interattivi dove il pubblico può muoversi, toccare, modificare l'ambiente visivo e sonoro.
Lo spettatore non è più osservatore, ma parte attiva dell'opera.
Refik Anadol (Turchia/USA)
Utilizza intelligenza artificiale e big data per creare visualizzazioni astratte e dinamiche.
Machine Hallucinations e Quantum Memories sono esempi di come l'arte possa dialogare con l'estetica algoritmica.
Le sue opere sono pensate per essere esperite in movimento, con uno sguardo mobile e fluido.
Es Nova (Italia)
Collettivo che ha presentato la mostra NOI a L'Aquila: un'esperienza immersiva che fonde arte visiva e ambientazione sonora.
Lo spettatore è avvolto da luci, suoni e immagini, in un percorso che stimola la percezione sensoriale.
Questi artisti propongono opere che richiedono tempo, silenzio e attenzione, opponendosi alla logica della velocità.
Tino Sehgal (Germania/UK)
Le sue "constructed situations" sono performance senza oggetti, dove il pubblico interagisce con interpreti umani.
Non è consentita la documentazione: l'opera esiste solo nel momento dell'incontro.
Un invito radicale alla presenza e alla relazione, lontano da ogni distrazione.
Agnes Martin (Canada/USA)
Le sue tele minimaliste, spesso monocromatiche o a righe sottili, richiedono uno sguardo lento e meditativo.
Martin parlava di "bellezza trascendente" e di arte come esperienza spirituale.
Le sue opere sfidano la cultura dell'immediatezza, chiedendo tempo e silenzio.
Gianni Colombo (Italia)
Pioniere dell'arte ambientale e interattiva, ma con un approccio che stimolava la riflessione corporea e percettiva.
Le sue installazioni, come Spazio Elastico, modificano la percezione dello spazio e invitano a una fruizione attiva ma non frenetica.
Connessioni con altri lavori di saggistica
Per chi vuole iniziare a esplorare questi temi, ma con strumenti da "addetti ai lavori", è utile mettere Bishop in dialogo con altri testi chiave:
Nicolas Bourriaud – Estetica relazionale (1998)
Qui si definisce l'arte come costruzione di relazioni sociali. Bishop, in passato, ha criticato questa visione, ma oggi la questione si ripropone: come si costruiscono relazioni in un'epoca di attenzione frammentata?
Jonathan Crary – 24/7. Il capitalismo e la fine del sonno (2013)
Crary descrive un mondo in cui il tempo di riposo e contemplazione viene eroso dal capitalismo digitale. La sua analisi si intreccia con Bishop: l'arte diventa un campo di resistenza alla logica della produttività continua.
Boris Groys – In the Flow (2016)
Groys riflette sull'arte nell'era dei flussi digitali. L'opera non è più un oggetto stabile, ma un frammento che scorre nel continuum delle immagini. Questo concetto dialoga direttamente con la percezione "distratta" descritta da Bishop.
Hal Foster – The Return of the Real (1996)
Foster analizza il ritorno dell'arte verso il corpo, il trauma, la materialità. In un contesto di attenzione volatile, la concretezza diventa un modo per riagganciare lo spettatore.
Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...
Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine
Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...
È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.