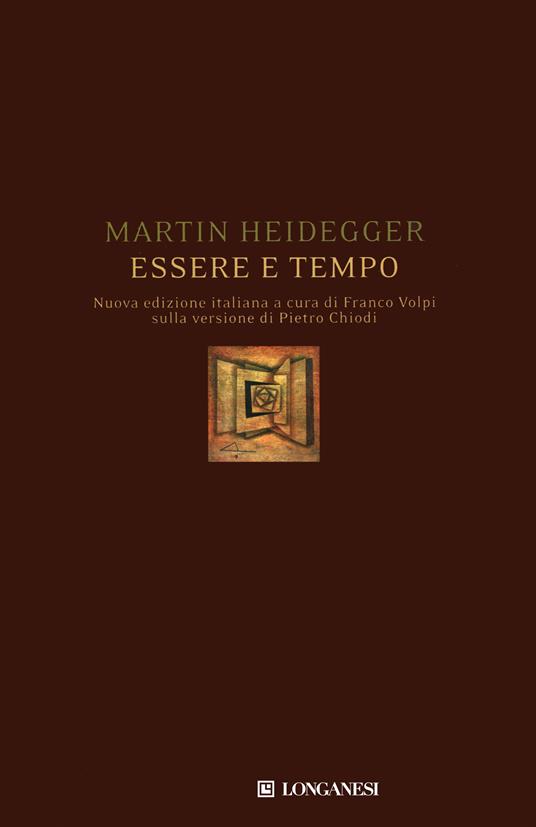La discesa nell'oscurità
All'inizio, Siffre tentò di mantenere una routine: mangiare quando aveva fame, dormire quando si sentiva stanco. Ma presto il tempo cominciò a sfaldarsi. Le ore sembravano minuti, i giorni un'unica colata indistinta. Le voci della mente presero vita, ombre inesistenti lo seguivano, la paranoia si insinuava tra le crepe della solitudine.
Senza il sole a scandire il ritmo, il suo corpo inventò un nuovo tempo: 36 ore di veglia seguite da 12 di sonno. Un ciclo alieno, ma coerente, che dimostrava l'esistenza di un orologio biologico indipendente dalla luce solare. Era una scoperta rivoluzionaria: il nostro cervello non è un semplice ricettore del tempo esterno, ma un creatore di tempo.
Il prezzo della scoperta
Se la scienza guadagnava una rivelazione, l'uomo pagava un tributo pesantissimo. Siffre perse la nozione del tempo e dei giorni: al secondo mese era convinto che fossero passate 24 ore, mentre in realtà erano quasi il doppio, 48. Smarriva parole, dimenticava pensieri a metà frase, oscillava tra euforia e disperazione. Per combattere il silenzio parlava con gli insetti, registrava la propria voce per non sprofondare nell'assenza.
Quando finalmente fu riportato in superficie, erano trascorsi 180 giorni reali. Ma per lui erano solo 151. Il tempo si era piegato, distorto, consumato dalla sua mente. Descrisse quell'esperienza come "una lenta discesa nella follia" e portò per anni le cicatrici di quella esperienza senza fine.
Un'eredità che guarda allo spazio
Eppure non si fermò. Continuò a ripetere gli esperimenti, spingendo ancora oltre i limiti dell'isolamento. I suoi studi aprirono la strada alla moderna cronobiologia, alle ricerche sul sonno, alla psicologia del tempo e persino alle missioni spaziali, dove astronauti affrontano lo stesso vuoto di riferimenti esterni.
La sua eredità è duplice: da un lato, il tributo alla resistenza dell'uomo, capace di reinventare la propria percezione del tempo; dall'altro, un monito sulla fragilità della mente, che può sgretolarsi se privata delle sue ancore.
La lezione di Michel Siffre
La storia di Michel Siffre ci insegna che il tempo non è solo qualcosa che scorre "fuori da noi", negli ingranaggi degli orologi o nel movimento del sole. È un'esperienza viva, che nasce dentro di noi, plasmata dal cervello. E, senza punti di riferimento, il tempo diventa liquido, si piega, si spezza, si frammenta.