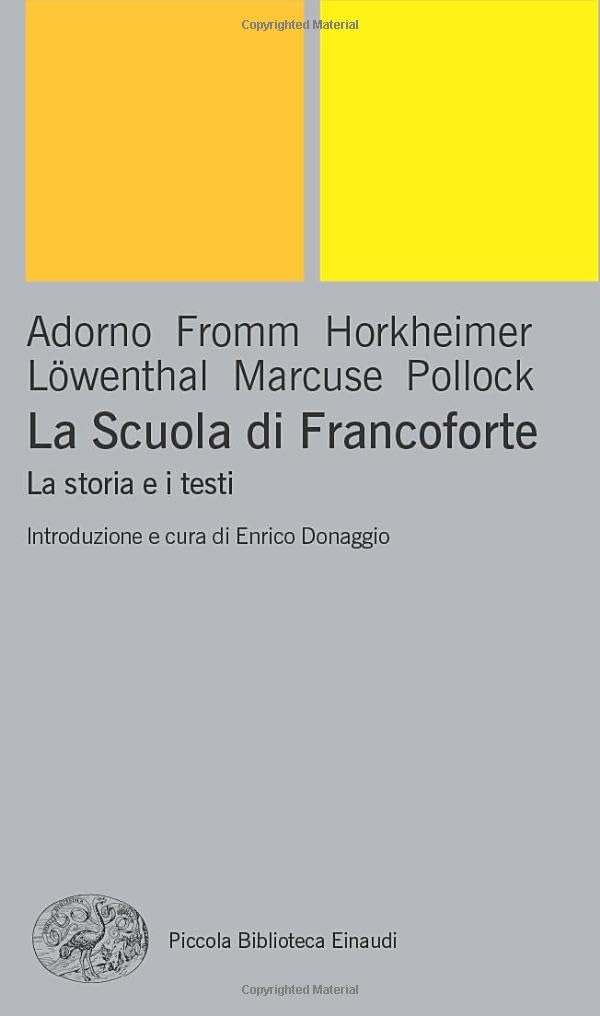Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...
L'artista vero: cultore della storia, grande umanista ed esploratore instancabile
L'artista autentico è colui che attraversa la storia dell'arte come si attraversa un terreno sacro. Conosce ogni svolta, ogni rivoluzione espressiva, ogni rivoluzione silenziosa. Non si accontenta mai: sperimenta, si mette in discussione, resiste alla tentazione della novità senza senso. Sa che la strada è impervia e solitaria, fatta di sacrifici e incognite. Non vive per il denaro — perché l'arte, quella autentica, non nasce da formule di mercato. Solo uno su un milione può trasformare questa passione in sostentamento. Non siamo davanti a un gesto fine a se stesso né a un vano compiacimento del sé. L'arte vera nasce dal desiderio urgente di lasciare un segno — qualcosa che renda il mondo più luminoso, più umano.
L'artista autentico non è semplicemente un produttore di immagini o suoni: è un agente ontologico, un essere che interroga il senso dell'esistenza attraverso il linguaggio simbolico. La sua opera non è mai decorativa, ma rivelatrice. In lui si incarna ciò che Theodor Adorno chiamava "l'autonomia dell'arte": una resistenza alla mercificazione, una forma di pensiero che si oppone alla logica funzionale della società tardo-capitalista.
Conoscenza come fondamento
L'artista autentico è un archeologo della sensibilità. Conosce la storia dell'arte non come repertorio, ma come campo di battaglia delle idee. Ogni rivoluzione espressiva — dal chiaroscuro caravaggesco alla dissoluzione della forma in Rothko — è per lui una tappa di un viaggio spirituale. Walter Benjamin parlava dell'aura dell'opera d'arte: l'artista vero ne è il custode, consapevole che ogni gesto creativo è un atto di responsabilità verso il passato e il futuro.
La tensione tra autenticità e alienazione
In una società dominata dalla logica dell'apparenza, come descritta da Guy Debord nella Società dello spettacolo, l'artista autentico è un eretico. Rifiuta la seduzione della novità vuota, del trend effimero. Vive una condizione di solitudine ontologica, simile a quella del filosofo esistenzialista: sa che la verità non è mai comoda, e che l'arte autentica nasce dal conflitto interiore, dalla crisi, non dalla conferma.
141. La vittoria della borghesia è la vittoria del tempo profondamente storico, perché è il tempo della produzione economica che trasforma la società, in permanenza e da cima in fondo. Per tutto il tempo durante il quale la produzione agraria rimane il lavoro principale, il tempo ciclico che resta presente al fondo della società dà vita alle forze coalizzate della tradizione, che freneranno il movimento. Ma il tempo irreversibile dell'economia borghese estirpa queste sopravvivenze su tutta l'estensione della terra. La storia che era apparsa fin qui come il solo movimento degli individui della classe dominante, è dunque scritta come storia di avvenimenti, è adesso compresa come movimento generale, e in questo severo movimento gli individui sono sacrificati. La storia che scopre la propria base nell'economia politica conosce adesso l'esistenza di ciò che era il suo inconscio, ma che tuttavia rimane ancora l'inconscio che essa non può portare alla luce. E' solo questa cieca preistoria, una nuova fatalità che nessuno domina, che l'economia mercantile ha democratizzato.
Il nuovo rinascimento underground: la rete e il cambiamento
Oggi, grazie ai social, l'underground artistico ha spalancato i suoi orizzonti. La rete ha abbattuto muri che sembravano invalicabili. Eventi culturali nascono quasi a costo zero, e artisti emergenti si intrecciano, creano associazioni, formano comunità: online, ma anche ben oltre, arrivando a oltrepassare i confini dei loro paesi d'origine.
In questo fervore pulsano energie genuine: menti curiose, cuori ardenti, ideali collettivi. Nascono progetti reali, mostre temporanee in spazi alternativi, collaborazioni nate da un like, dal commento di un follower, da uno scambio notturno in chat. Si lavora non per il successo facile, ma per costruire qualcosa di vivo e condiviso.
Il rischio della superficialità: i "pseudo-artisti"
Ma dove c'è luce, l'ombra non tarda ad arrivare.
Ci sono i "pseudo-artisti": improvvisatori rapidi, convinti che l'arte sia una scorciatoia verso fama e ricchezza. A volte sfidano l'ignoranza del pubblico, copiando spudoratamente i grandi, tanto che nei piccoli contesti locali possono farla franca. Inconsapevolmente, sottovalutano la potenza della rete — che registra, archivia, espone. E la rete non perdona.
Questo tipo di arte, vuota e senza nucleo, è dannosa: disonora chi ci crede veramente, impoverisce l'ecosistema stesso dell'arte. È un'onta che pesa non tanto sulla creatività viva, ma sul rispetto verso chi rinasce ogni giorno nel proprio lavoro.
La vocazione dell'artista: un atto di responsabilità
L'artista vero è innanzitutto un ricercatore: non cerca la luce per sé, ma per il mondo. Fa dell'arte un atto di solidarietà estetica e sperimentale, di riflessione, di accensione. Non è un'aspirazione a restare nella memoria personale, ma un'elevazione condivisa. La fatica è parte dell'atto creativo, la rinuncia al facile applauso è dignità.
Rete e autenticità: far fiorire l'arte, non svilirla
La rete offre un terreno fertile, ma non garantisce la genuinità. La democratizzazione è un'opportunità enorme, ma porta con sé il rischio dell'effimero, del prodotto pronto per consumare e dimenticare. È qui che l'artista si misura: mette in rete la sua voce, ma la custodisce con coerenza, rigore, passione.
È questa tensione — tra il desiderio di essere ascoltato e quello di essere credibile — che distingue il vero artista dai tanti che, invece, si accontentano del riverbero digitale.
Coltivare il vero, smascherare il vuoto
L'artista vero è una creatura rara, ma necessaria. Sa che l'arte è via, non meta. La rete ha reso possibili connessioni incredibili, ma ha anche amplificato le difficoltà di restare autentici. Dobbiamo coltivare quei pochi che lo fanno davvero — e non dare spazio a chi svilisce questa missione.
Sacrificio e marginalità
Pierre Bourdieu ci insegna che il campo artistico è regolato da capitali simbolici e lotte di legittimazione. L'artista autentico spesso rifiuta queste dinamiche, consapevole che la sua ricerca non può essere misurata in termini di successo economico. Vive ai margini, ma non per scelta estetica: è il prezzo della coerenza etica. La sua opera è testimonianza, non prodotto.
Umanesimo radicale
L'artista vero è un umanista radicale. Non nel senso accademico, ma nel senso di chi crede che l'arte possa ancora illuminare l'umano. La sua creazione è un atto di cura, un tentativo di rendere il mondo più abitabile, più sensibile. In questo, si avvicina alla figura del guaritore simbolico: colui che, attraverso la bellezza, tenta di sanare le ferite invisibili della società.
Ma quanto gli attori del sistema dell'arte — galleristi, curatori, critici, musei, media — sono artefici o complici di chi, nonostante lacune di contenuto, riesce a emergere? E in qualche modo, a volte, "favorirne la sopravvivenza" nel sistema.
Il sistema dell'arte: una macchina complessa, spesso ingiusta
1. Disuguaglianze di accesso e "capabilities" diseguali
Non tutti gli artisti partono dallo stesso punto: alcuni hanno alle spalle formazione accademica, contatti in città d'arte, condizioni economiche favorevoli. Altri sono isolati, emergono in contesti periferici o non hanno facilitazioni. Tali differenze compromettono la meritocrazia e favoriscono chi sa meglio muoversi — anche senza qualità intrinseca.
2. Le élite culturali e la costruzione delle narrazioni dominanti
Critici, curatori, editori e istituzioni hanno un potere enorme nel legittimare opere, artisti e tendenze. La loro scelta non è mai neutrale: combina interessi economici, strategici, identitari. Quando decidono di supportare opere mediocri o autopromozionali, il sistema le trova una legittimazione culturale e di mercato. Ne abbiamo già scritto qui.
3. Polarizzazione del mercato
Un mercato sempre più concentrato nelle mani di pochi "mega-dealer" (come Gagosian, Hauser & Wirth, Zwirner) rafforza artisti già affermati. Tutti gli altri — inclusi i mediocri — rimangono ai margini, con pochi spazi di visibilità autentica.
4. Galleristi e strategie commerciali
Le gallerie dominanti investono su pochi emergenti considerati "promettenti". Al contempo, gonfiano i prezzi d'ingresso, creando una dinamica di esclusività difficilmente accessibile per i più. Questo modello alimenta un mercato selettivo e spesso clientelare.
5. Ruolo degli intermediari
Critici, curatori, advisor, giornalisti, fiere, aste e piattaforme digitali costituiscono il sistema — e possono sia promuovere l'arte vera sia alimentare il consumo di arte "artefatta", pedissequamente manipolata. Quando privilegiano la visibilità veloce o il sensazionalismo, contribuiscono a svalutare il valore autentico dell'opera o dell'artista.
Il parere della comunità: sguardo disincantato dagli addetti ai lavori
Chi ha lavorato due anni nel dietro le quinte dell'arte contemporanea ha descritto un ambiente chiuso, spesso autoreferenziale e guidato dal marketing, dove persino operazioni tecniche vengono svolte da figure sotto-pagate — e dove "gran parte delle opere valutate decine o centinaia di migliaia di euro sono pattume".
Questa testimonianza pragmaticamente amara conferma quanto il sistema possa essere guidato, molto spesso, da logiche economiche o di visibilità, più che da contenuti.
L'ambivalenza sistemica: artefici o complici?
Il sistema dell'arte ha certamente un ruolo attivo nella promozione — o nell'esclusione — di artisti. In alcuni casi, queste figure:
-
sono artefici, perché selezionano, valorizzano, curano percorsi di artisti autentici e perseveranti;
-
sono complici, quando supportano o ignorano contenuti di scarsa qualità, magari perché convenienti o convenienti dal punto di vista commerciale o di networking;
-
sono corresponsabili, quando la mancanza di una vera critica e la cultura del consenso frenano il confronto serio e disinnescano la funzione rivoluzionaria dell'arte.
Per concludere e sintetizzare
-
Il sistema dell'arte non è neutrale: favorisce chi ha mezzi, contatti e capacità di autopromozione — non sempre legate a genuino talento;
-
Le élite culturali (critici, curatori, galleristi) costruiscono narrazioni che legittimano chi opera dentro i canoni o il mercato, anche a discapito della qualità;
-
Le dinamiche di mercato amplificano le distanze tra pochi fenomeni di massa e una moltitudine di soggetti marginali, alcuni autentici, altri purtroppo mediocri;
-
I testimoni del settore denunciano aperture chiuse, opere sopravvalutate e una crisi del discorso critico.
Per approfondire:
Il valore dell'arte come linguaggio nel pensiero filosofico – Un saggio che esplora il pensiero di Platone, Kant, Hegel, Hölderlin e altri
Heidegger e l'autenticità: l'arte di essere nel mondo – Un percorso guidato per riflettere sull'autenticità nell'arte e nella vita
Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine
Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...
È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.