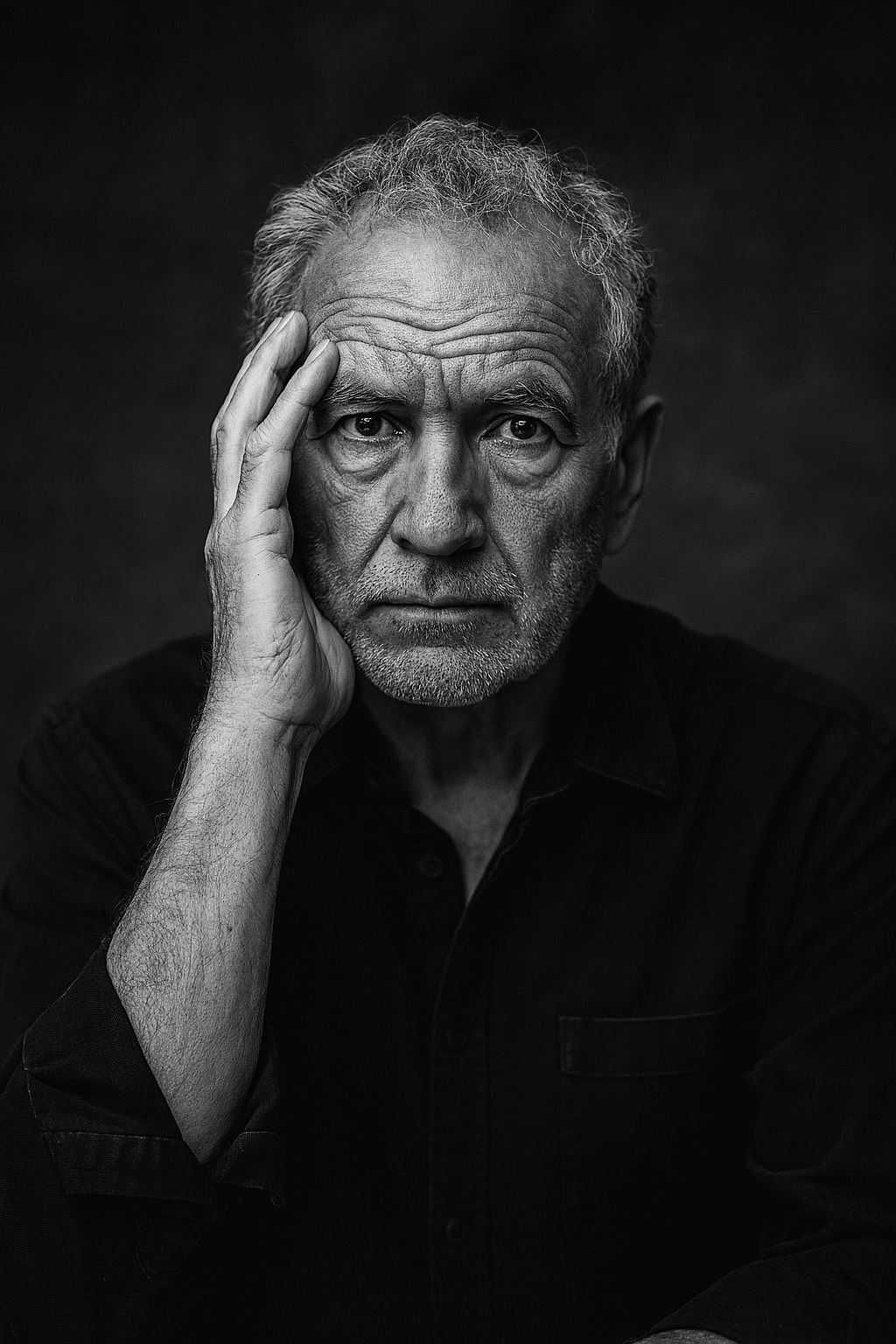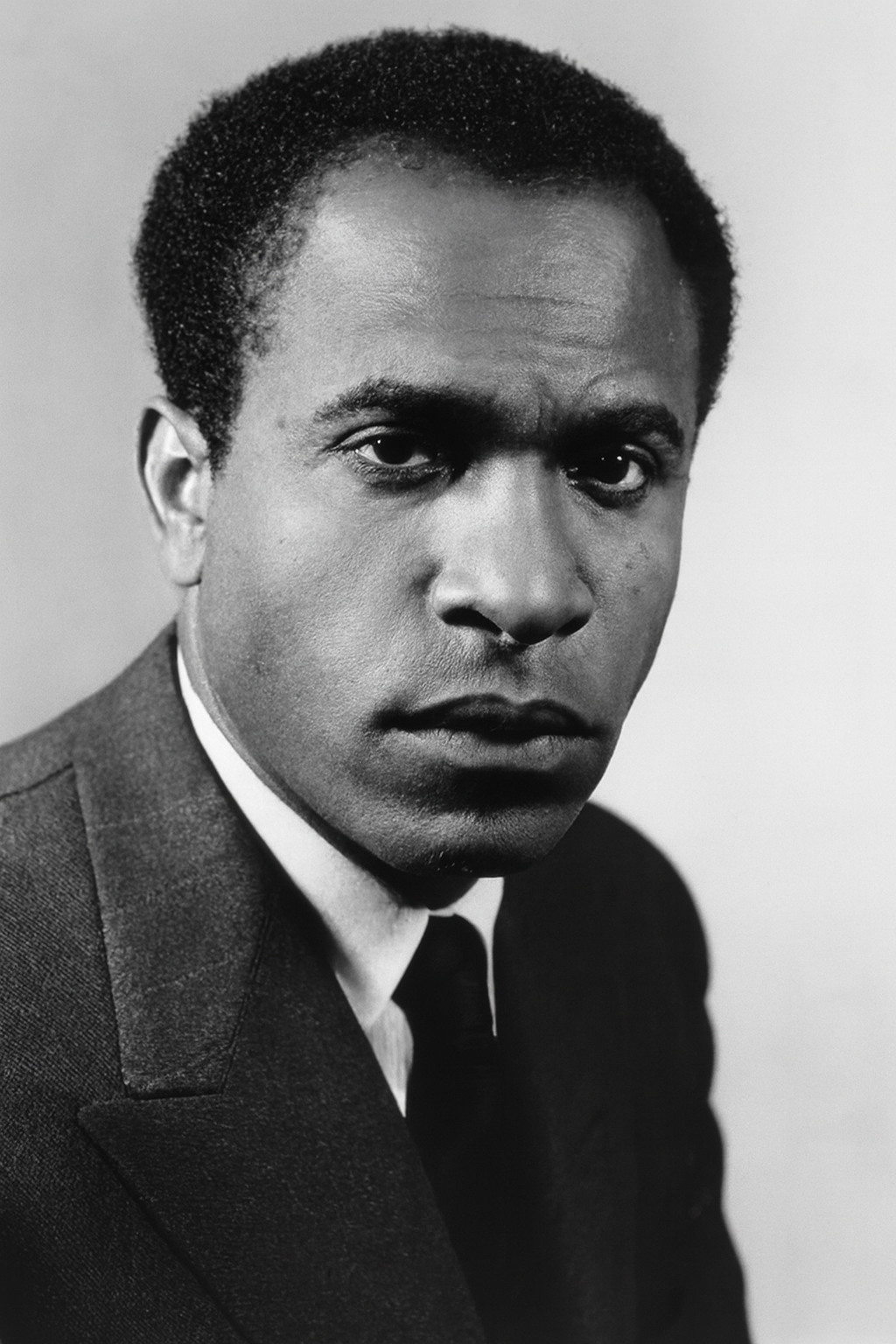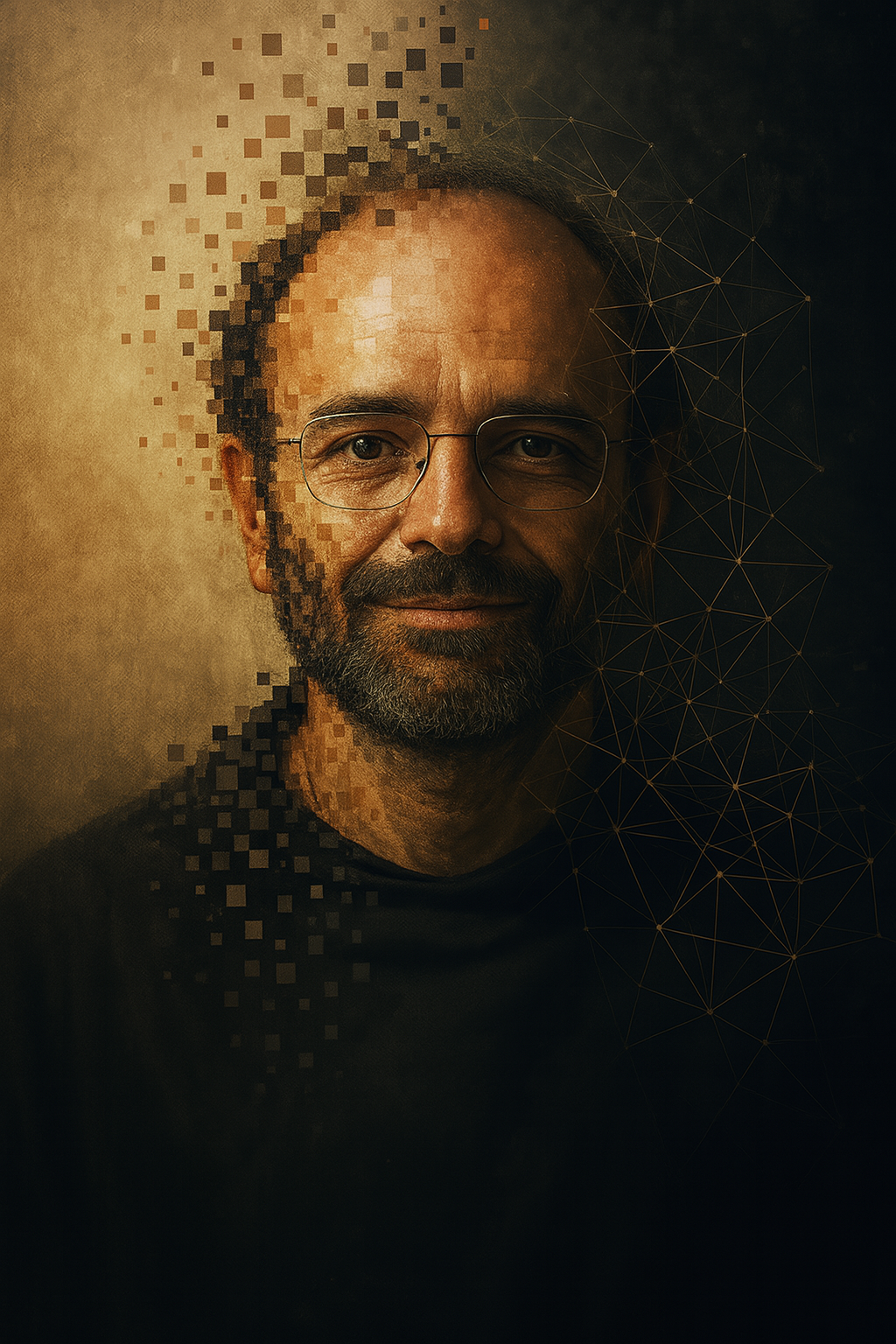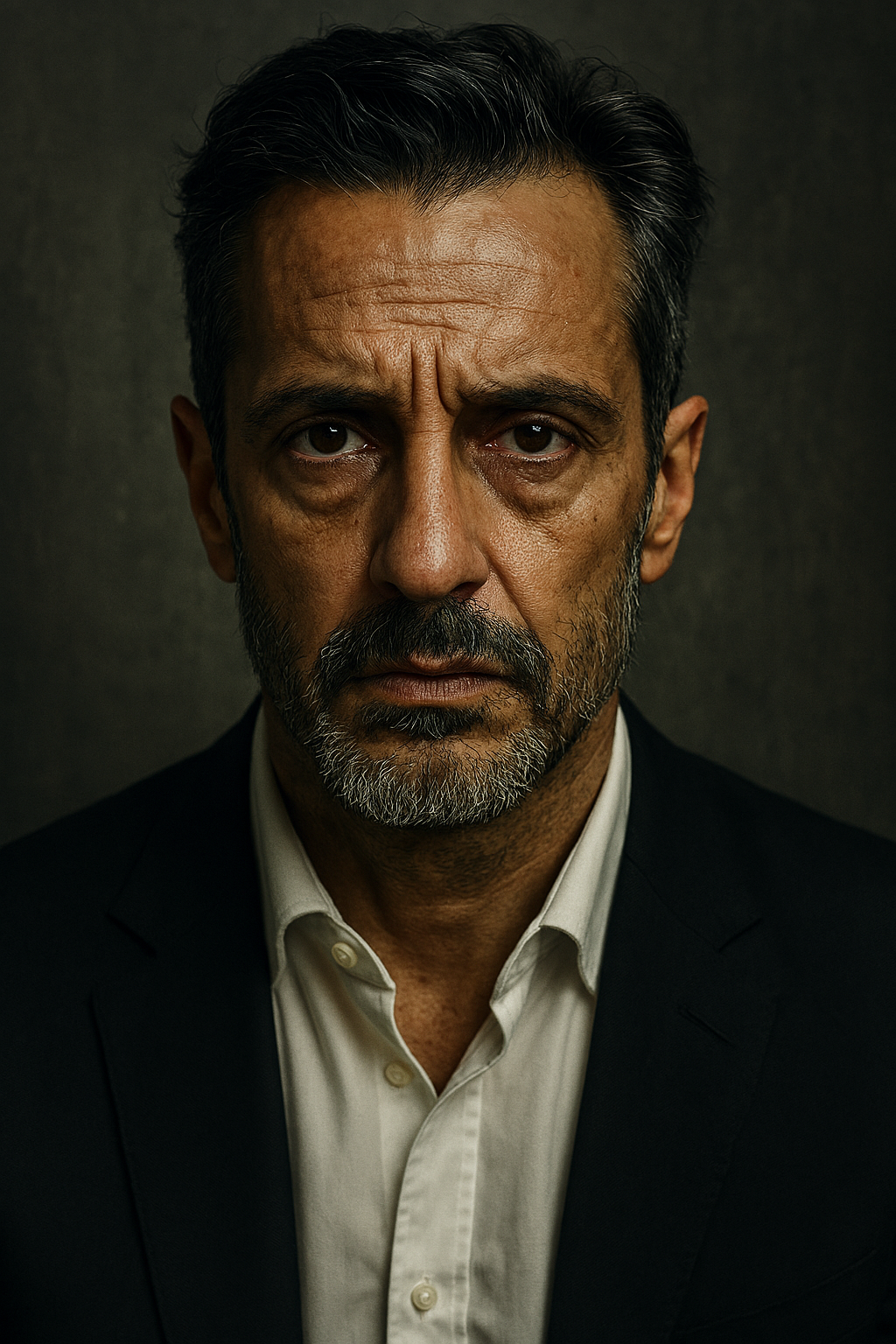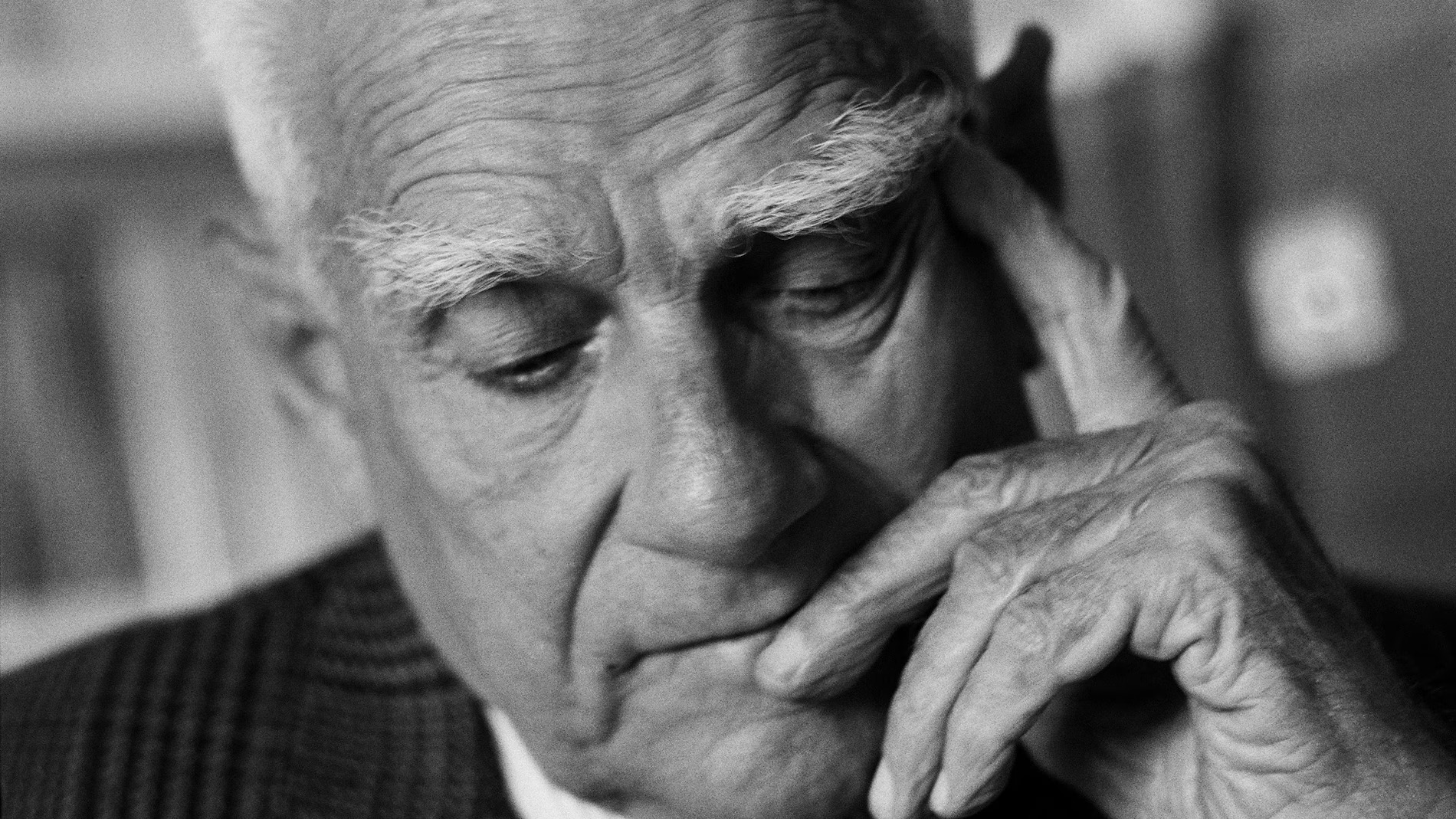La narrazione come funzione cognitiva e culturale: un nuovo paradigma interpretativo
Le narrazioni sono ovunque: riempiono biblioteche e archivi digitali, abitano la memoria degli individui e dei popoli, plasmano l'immaginario collettivo e personale. Eppure, paradossalmente, proprio mentre il mondo si satura di storie, l'analisi narrativa sembra attraversare una crisi profonda. Dopo l'epoca dell'esegesi, si sono succedute correnti interpretative come lo strutturalismo, l'ermeneutica, la psicanalisi, il femminismo, la decostruzione — solo alcune tra le molteplici scuole che hanno tentato di decifrare il fenomeno narrativo. Il risultato è una frammentazione teorica che rende difficile, se non impossibile, un approccio condiviso.
In questo contesto, è necessario ripensare radicalmente il modo in cui comprendiamo la narrazione. Dopo aver ripercorso la storia della narratologia classica e dei suoi principali autori, propongo un cambio di prospettiva: considerare la narrazione non come semplice arte o tecnica, ma come funzione cognitiva evolutiva. Le scienze biologiche e neurobiologiche offrono modelli che ci permettono di interpretare la narrazione come un meccanismo neuronale fondamentale, attraverso cui il cervello umano si orienta nel tempo, organizza gli eventi, attribuisce senso all'esperienza.
La narrazione, in questa visione, non è solo un prodotto culturale, ma una strategia cognitiva che ci consente di tenere insieme i frammenti della nostra vita. È ciò che trasforma il caos in ordine, l'accadere in significato. E non è un processo passivo: è un gioco cognitivo attivo, che può essere analizzato attraverso i modelli matematici della teoria dei giochi. Da questa prospettiva, le storie non sono solo specchi della realtà, ma strumenti evolutivi che hanno guidato la cultura umana verso forme sempre più complesse di cooperazione.
Chiunque abbia pianto davanti a un film, si sia sentito trasformato da un romanzo, o abbia trovato conforto in una commedia, ha sperimentato la potenza della narrazione. Le storie ci nutrono, ci formano, ci sopravvivono. La nostra vita stessa è una narrazione, e ha senso solo nella misura in cui siamo capaci di raccontarla. Ma cosa accade davvero nel nostro cervello quando viviamo un'esperienza narrativa? Come funziona questo misterioso meccanismo che ci permette di dare coerenza al nostro vissuto?
Le storie possono ispirare, motivare, guarire — come accade a Sharāzād ne Le mille e una notte — ma possono anche distruggere. In nome di narrazioni come la teoria della razza, la lotta di classe o la storia della salvezza, sono state perpetrate atrocità indicibili. Platone ci mette in guardia dalle cattive storie, Aristotele ci insegna a giudicarle. Per millenni, grandi narrazioni religiose e laiche si sono contese il senso ultimo della Storia, fino alla crisi del postmoderno, che ha messo in discussione la possibilità stessa di una narrazione universale.
La narrazione è inevitabile. È inscritta nel nostro linguaggio, nella nostra percezione del tempo, nella nostra corporeità. Dalla pittura rupestre alla danza, dal racconto orale alle immagini digitali, l'essere umano ha sempre raccontato storie. E ogni racconto è inevitabilmente parziale, artefatto, manipolato: se fosse puro, non sarebbe racconto, ma realtà. Il problema non è stabilire se una narrazione sia importante o giusta, ma comprendere come funziona.
Il termine "narrazione" racchiude molteplici significati. La distinzione tradizionale tra narrazione e descrizione, basata sul riferimento al tempo, è insufficiente: anche le descrizioni raccontano un tempo, seppur rallentato o sospeso. La narrazione è meglio intesa come funzione cognitiva trasversale, che attraversa ogni forma di esperienza umana. Le distinzioni tra finzione e resoconto, tra spettatore e lettore, non aiutano a cogliere l'essenza del fenomeno narrativo. Perché ciò che conta non è il medium, ma il processo mentale che ci consente di dare senso.
"Perché ciò che ci interessa non è il modo in cui la storia viene fruita, ma il modo in cui essa agisce sulla mente umana. Raccontare storie non è un lusso: è una necessità. È il modo in cui diventiamo umani".