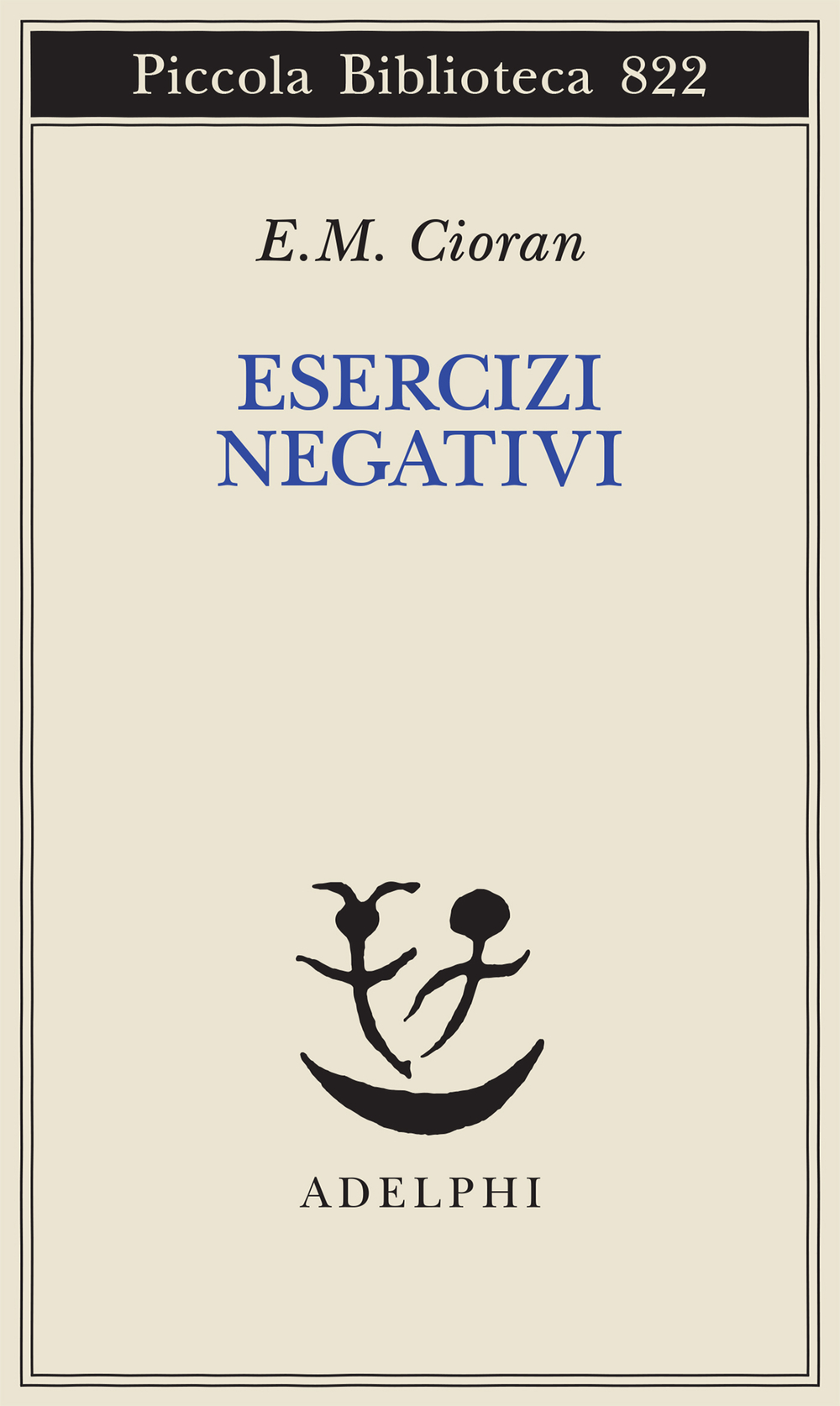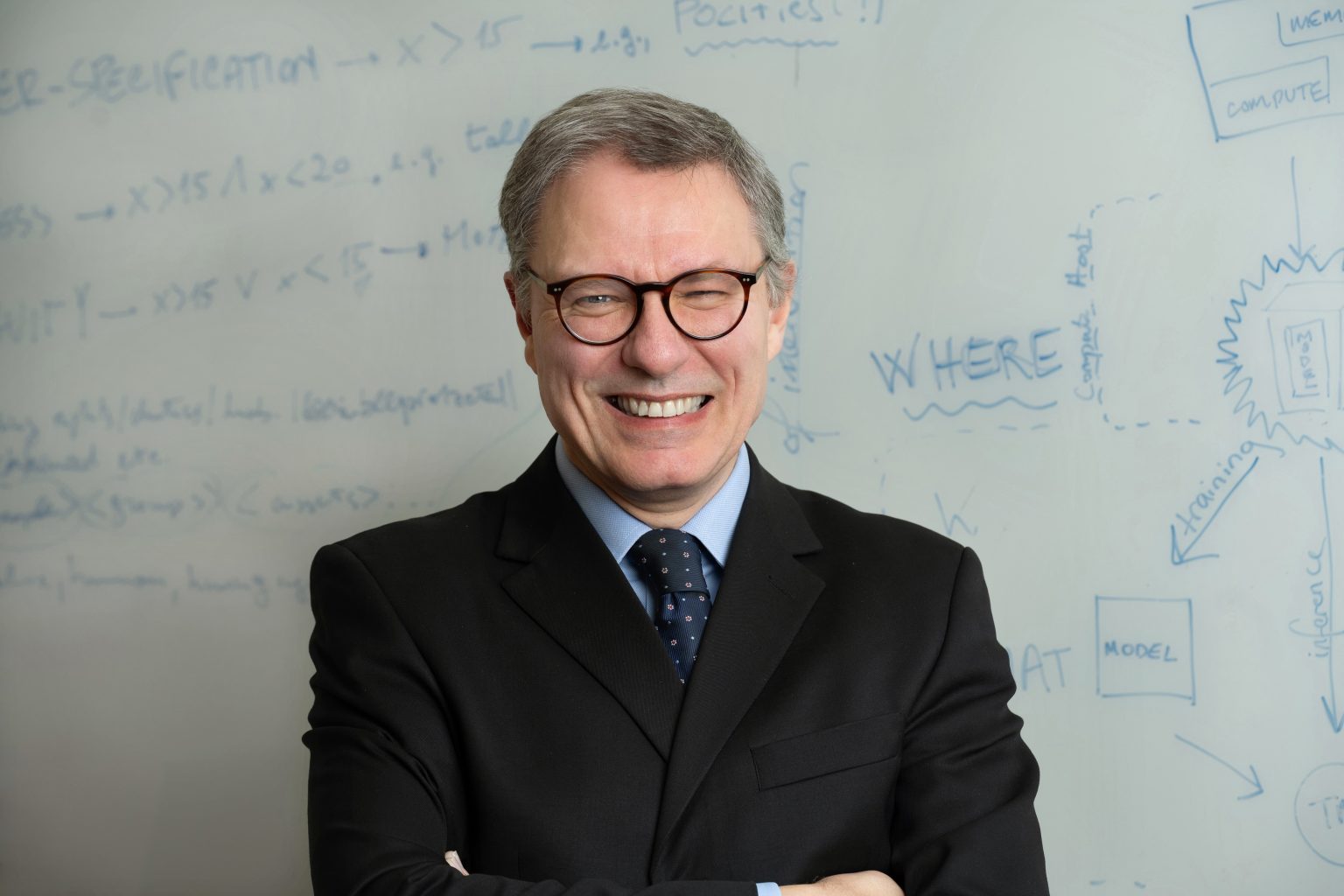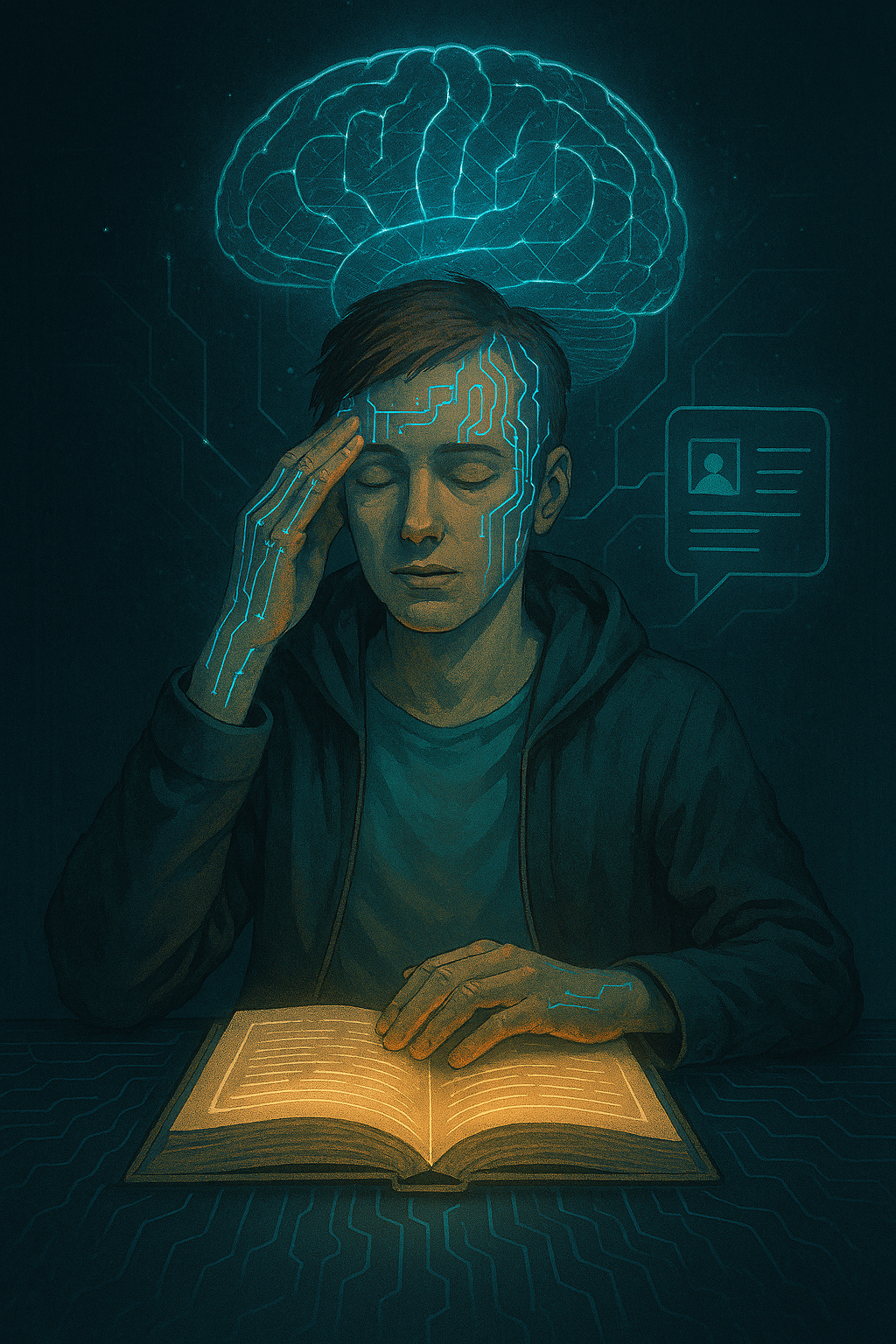
Cioran, l’incendio del pensiero. Anatomia degli Esercizi negativi
Non si legge Cioran: si viene letti da lui. Si viene scorticati, ridotti all'osso, e poi lasciati lì, nudi, a contemplare l'assenza di senso come un altare rovesciato.
Il pensiero come decomposizione
Esercizi negativi non è un libro: è un contagio. Non offre tesi, non costruisce sistemi. È un diario di combustione, un prontuario di smascheramenti. Ogni frammento è un colpo di scalpello contro l'illusione, un'epigrafe incisa sul marmo della disperazione lucida. Cioran non argomenta: incide. Non consola: brucia. È il chirurgo dell'anima che opera senza anestesia, il mistico senza Dio che ha fatto del dubbio una liturgia e della malinconia una professione. Cioran non è un nichilista nel senso banale del termine. Il suo è un nichilismo attivo, febbrile, che non si accontenta di negare ma vuole vedere cosa resta dopo la rovina. È un pensiero che non cerca salvezza, ma verità. E la verità, per lui, è ciò che resta quando tutte le illusioni sono crollate. Scrive Vincenzo Fiore: "Non c'è filosofia, ma un incendio che riduce in cenere ogni certezza". Ecco la chiave: Cioran non pensa per costruire, ma per disfare. Non per spiegare, ma per esporre. Il suo pensiero è un'epidermide scorticata, una lingua che sanguina. A proposito del volume che Fiore ha curato e tradotto Il nulla per tutti. Lettere ai contemporanei di Emil Cioran (Mimesis). Il testo raccoglie le lettere inedite del filosofo romeno a grandi intellettuali del secolo scorso, fra cui: Samuel Beckett, Ernst Jünger, Gabriel Marcel, Carl Schmitt, Elie Wiesel, Marguerite Yourcenar, María Zambrano.
Un'etica della disillusione
Eppure, in questo esercizio di decomposizione, c'è una forma di etica. Un'etica della lucidità, della non-complicità. Cioran non si rifugia nel cinismo, ma lo attraversa. Non si arrende al nulla, ma lo contempla con occhi spalancati. È il filosofo che ha scelto di non mentire, nemmeno a se stesso.
Come scrisse in Sillogismi dell'amarezza:
Un libro deve frugare nelle ferite, anzi deve provocarle. Un libro deve essere un pericolo.
Esercizi negativi è quel pericolo. È il libro che non si legge per capire, ma per essere trasformati. O, più precisamente, per essere disillusi con grazia.
Cioran non si legge: si viene letti da lui. È un'esperienza che scortica, che riduce all'osso, che lascia nudi davanti all'assenza di senso, come se ci si trovasse di fronte a un altare rovesciato. I testi raccolti in Esercizi negativi offrono un privilegio raro: quello di penetrare nel laboratorio del suo pensiero, di assistere in presa diretta al suo distillarsi. È come osservare il passaggio da un Cioran degli inizi, più lirico, più scarmigliato, più apertamente provocatorio, alla folgorante condensazione del frammento.
Ingrid Astier osserva che Esercizi negativi mostrano l'esplosione vissuta e il lento lavoro di rifinitura dello stile. Basta scorrere i titoli di alcuni capitoli per cogliere la forza dirompente di un libro dal quale non si esce indenni: L'assoluto e le sue caricature, L'improbabile come salvezza, Il suicidio come strumento di conoscenza, Tra Dio e il verme, Del solo modo di sopportare gli uomini. Ogni titolo è già una ferita aperta, una soglia che introduce a un pensiero che non cerca consolazione, ma verità.
Molti anni più tardi, lo stesso Cioran affermerà che un libro deve frugare nelle ferite, anzi deve provocarle. Un libro deve essere un pericolo. In queste pagine, quell'intento profondo si rivela con chiarezza: alla minaccia dell'accecamento, Cioran preferisce la lucidità dell'insonnia. Non c'è riposo nel suo pensiero, ma una veglia costante, una tensione che non si placa, una ricerca che non si concede tregua.
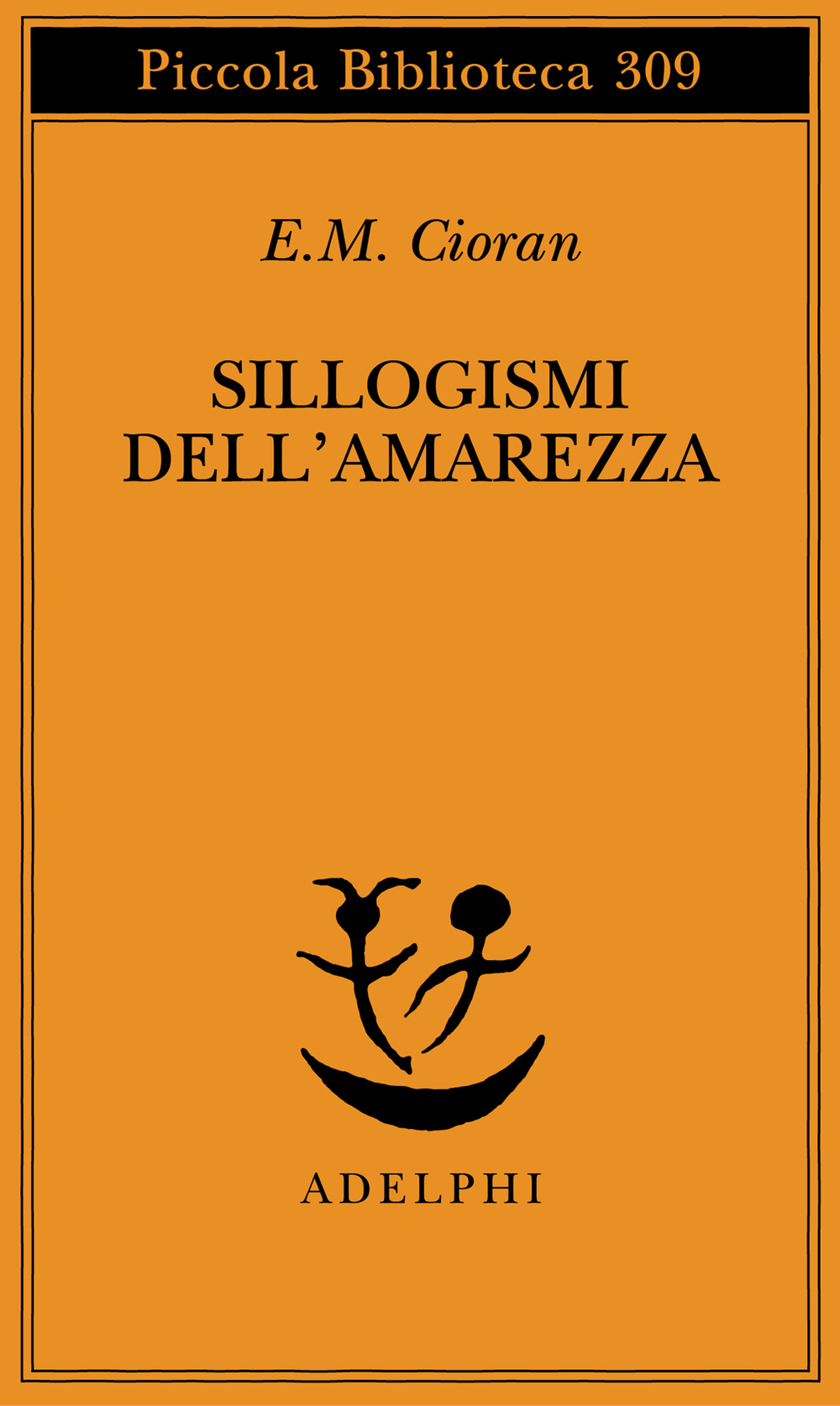
Tra dieci anni il mondo del lavoro non sarà semplicemente cambiato: sarà stato riscritto. Le tecnologie che oggi osserviamo con curiosità – l'Intelligenza Artificiale generativa, la robotica collaborativa, i sistemi autonomi – diventeranno infrastrutture invisibili, come l'elettricità o il Wi‑Fi. Chi oggi ha tredici anni entrerà all'università nel...
Le città‑specchio della Cambogia: dove gli schiavi digitali alimentano l’economia del crimine
Ci sono luoghi nel mondo che sembrano progettati per non essere guardati davvero. Città che brillano di luci artificiali, dove i casinò sono sempre aperti ma sempre vuoti, dove i resort sorgono come miraggi nel deserto sociale che li circonda. A Sihanoukville, nel sud della Cambogia, questa estetica dell'abbondanza è solo una facciata: dietro le...
È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di Isla, la nuova rivista online dedicata alla cultura visiva e all'arte contemporanea. Isla si propone come una piattaforma dinamica e ispiratrice, che esplora le ultime tendenze e i talenti emergenti nel mondo dell'arte, del design, della fotografia e dell'architettura.